
Prendiamo spunto da una legge francese per affrontare alcune sfide della traduzione in contesti penali. Gli argomenti non riguardano solo la lingua francese e sono interessanti anche per chi traduce testi di argomento non giuridico. L’uso corretto del linguaggio e delle fonti, le scelte da fare. Le norme di nuova promulgazione pongono problemi specifici, perché non trovano riferimenti diretti fra gli ordinamenti e nella giurisprudenza.
La traduzione di testi concernenti una legge nuova pone problemi specifici. Prendiamo spunto qui dalla legge francese detta «Legge sui separatismi» per individuare alcune sfide della traduzione di fattispecie penali. Gli argomenti non riguardano solo la lingua francese, possono essere facilmente applicati a ogni altra lingua e sono interessanti anche per chi non si occupa di testi giuridici. Il progetto di legge da cui è tratto il testo che utilizziamo come esempio, infatti, è molto discusso nei media, anche fuori dalla Francia. E’ possibile che debbano confrontarvisi anche professionisti che traducono articoli o altri testi di attualità non concernenti il merito specifico di questo provvedimento: opinioni varie, commenti di politici o sociologi e simili.
La traduzione di una disposizione penale è sempre delicata. L’uso corretto del linguaggio è essenziale per la comprensione e l’applicabilità della disposizione. Questa dev’essere formulata in modo chiaro per la sua finalità, secondo criteri di sufficiente determinatezza. Quando una fattispecie penale è nuova o rara, si hanno conseguenze anche sul linguaggio e sulla traduzione: mancano norme paragonabili nei diversi ordinamenti; l’assenza della giurisprudenza può rendere difficile circoscrivere il significato concreto dei suoi elementi descrittivi e normativi.
| Legga anche: >Linguaggio giuridico e traduzione |
Scopo di questo articolo non è discutere il contenuto della legge presa ad esempio, ma di coglierne spunti per la tecnica di traduzione validi anche in altri contesti, restando nel recinto dei problemi legati alla traduzione. Di fronte al diffondersi dei processi di traduzione con intelligenza artificiale, inoltre (si veda anche >qui), questa analisi mostra che una traduzione corretta nei contenuti, nella terminologia e nell’idiomatica richiede scelte consapevoli da parte di un occhio umano, capace di svelare le logiche più profonde del testo.
Tradurre una fattispecie nuova: la norma penale di partenza
La «Legge sui separatismi» è sorta da un’iniziativa del presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, che ha annunciato provvedimenti più severi dinanzi al rischio che l’estremismo religioso comporti la difficoltà di garantire i diritti costituzionali in alcune aree del territorio dello Stato. In tali zone tenderebbero a prevalere usi sociali non compatibili con i principi fondamentali della Repubblica, a danno, in particolare, della laicità dello Stato, della libertà di espressione e di altre libertà fondamentali. In sede di discussione, il progetto è stato ridenominato «Progetto di legge a sostegno dei principi repubblicani.»
L’articolo 25 del progetto introduce una nuova fattispecie penale: il divieto di diffondere informazioni sulla vita privata dei cittadini allo scopo di metterne in pericolo la sicurezza. La nuova norma sanziona i malintenzionati che diffondono dati sul domicilio, sul luogo di lavoro o su altri aspetti della vita di una persona o dei suoi familiari, con l’intento di esporla ad aggressioni o minacce. Prende spunto da fatti accaduti, in particolare dal recente omicidio di un docente, reso possibile proprio sulla base di informazioni private fatte circolare via Internet.
Abbozzo di traduzione e prima analisi della nuova norma
Leggiamo la nuova disposizione penale in lingua originale:
«Le fait de révéler, diffuser ou transmettre, par quelque moyen que ce soit, des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d’une personne permettant de l’identifier ou de la localiser, dans le but de l’exposer, elle ou les membres de sa famille, à un risque immédiat d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique, ou aux biens, est puni de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.»
Abbozziamone una prima traduzione, meramente letterale e senza pretesa di dettaglio, che modificheremo poi.
«Il fatto di rivelare, diffondere o trasmettere con qualunque mezzo informazioni relative alla vita privata, familiare o professionale di una persona che permettano di identificarla o localizzarla, allo scopo di esporre la persona stessa o i componenti della sua famiglia al rischio immediato di offesa alla vita o all’integrità fisica o psichica o ai suoi beni, è punito con la reclusione di tre anni e con un’ammenda di 45 000 euro.»
| Legga anche: >Le parti nei procedimenti sommari d’ingiunzione |
Analizziamo il nuovo reato: in corsivo, alcune espressioni che è utile tenere a mente, quando si parla di diritto penale. Si tratta di un reato comune: a differenza dei reati propri, qui la qualificazione soggettiva dell’agente, cioè il ruolo svolto da chi commette il reato, non rileva ai fini della sua punibilità. E’ punito chiunque lo commetta. I beni giuridici tutelati dalla norma, ossia gli elementi naturali o patrimoniali che la norma protegge, sono molteplici: l’ordine pubblico, la riservatezza della vita privata, ma, soprattutto, la vita, l’integrità fisica e psichica nonché il patrimonio della persona.
Tradurre una norma penale nuova: elementi costitutivi
L’elemento oggettivo della norma è la condotta posta in essere per giungere all’evento. In questo caso, è la diffusione di informazioni «relative alla vita privata, familiare o professionale di una persona che permettano di identificarla o localizzarla.» Siamo in presenza di un reato di pericolo, non di un reato di evento. La condotta è punita anche se la persona della quale sono state diffuse le informazioni non viene poi materialmente aggredita o lesa. La ratio della norma (cioè il suo scopo sociale) è impedire la diffusione delle informazioni con intento malevolo, anche se dalla diffusione non deriva un altro o più grave pregiudizio (omicidio, lesioni, offesa al patrimonio).
Secondo taluni, i reati di pericolo, in quanto reati di mera condotta, sono senza evento, poiché non colpiscono in presenza di un evento naturalistico (una modificazione della realtà tangibile), ma quando il bene tutelato viene solo messo in pericolo. Secondo un’altra interpretazione, ormai prevalente, nei reati di pericolo l’evento è il presentarsi del pericolo stesso: non un evento naturalistico ma un evento giuridico, non tangibile ma ben presente. (Cfr. Franceschetti P. – Reato, in: >Altalex, 13.1.2017. Messina S.D., Spinnato G – Manuale breve di diritto penale, Giuffrè, Milano, 2012).
L’elemento soggettivo del reato di cui stiamo parlando, ossia la condizione psicologica del soggetto attivo – o agente – che commette il fatto, è la coscienza e volontà di ledere il soggetto passivo (la vittima) esponendolo al pericolo immediato di offesa. Siamo in presenza di un dolo, in particolare di un dolo specifico: la diffusione delle informazioni è punita solo se avviene con l’intento esplicito di esporre la vittima a quel preciso rischio (ma potrebbe essere sanzionata da altre disposizioni, ad esempio da quelle sulla protezione dei dati personali o sulla riservatezza della vita privata).
| Legga anche: >Terminologia fiscale: tassa, tributo, imposta… |
Avviamoci a una traduzione adeguata
Proviamo ora a formulare correttamente in lingua italiana le poche righe di questa nuova norma. Sappiamo di essere in presenza di un reato comune, di pericolo, il cui elemento soggettivo è il dolo specifico. Conosciamo altresì l’elemento oggettivo del reato, i beni giuridici tutelati e la pena prevista dalla norma. Ricerchiamo allora dei reati aventi queste caratteristiche, nell’ordinamento italiano e in quello svizzero in lingua italiana, per trarne ispirazioni.
Un esempio di reato di pericolo, molto noto in Italia, è l’Associazione per delinquere, art. 416 CP (IT):
Associazione per delinquere – «Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all’associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. […].»
(Art. 416 CP)
In Svizzera, questa fattispecie è coperta dal reato di Organizzazione criminale, art. 260ter CP (CH):
Organizzazione criminale – «Chiunque partecipa a un’organizzazione che tiene segreti la struttura e i suoi componenti e che ha lo scopo di commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, chiunque sostiene una tale organizzazione nella sua attività criminale, è punito una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.»
(Art. 260ter CP)
| Legga anche: >Licenza, autorizzazione o concessione? |
Le fonti della terminologia: tra un ordinamento e l’altro
La citazione di questi due articoli è utile anche per un altro motivo, interessante per chi traduce. Il reato di Organizzazione criminale è stato introdotto nell’ordinamento svizzero nel 1994. Le culture penalistiche di alcuni Stati non conoscono (o conoscono in modo diverso) la nozione di reato di pericolo. In tali Paesi, diverse fattispecie di pericolo sono state introdotte solo di recente. La loro assenza rendeva difficile perseguire, ad esempio, la preparazione di atti terroristici, la cui repressione può prevenire il verificarsi gravi fatti violenti. La mancanza di questi reati, inoltre, rendeva impossibile l’estradizione di criminali autori di queste condotte di pericolo. Il presupposto dell’estradizione, infatti, è che il reato ascritto al reo sia previsto in entrambi gli Stati, quello richiedente e quello richiesto.
Le conseguenze per la traduzione sono che in alcune lingue può essere difficile trovare le terminologie adeguate a tradurre norme o commenti sui reati di pericolo, poiché la cultura sottostante ha un diverso concetto di queste fattispecie. Inoltre, nei casi in cui sono stati introdotti in tempi successivi, i reati di pericolo possono trovarsi in leggi penali extracodicistiche o in integrazioni alle norme esistenti. Richiedono perciò maggiore attenzione nella ricerca.
| Legga anche: >Arrestato, fermato, citato… quando e dove? |
Tradurre una fattispecie penale nuova: l’analisi
Tornando al nostro testo d’esempio, osserviamo quale linguaggio utilizzano reati che presentano analoghi elementi costitutivi. Dobbiamo descrivere adeguatamente, nella nostra traduzione, queste informazioni:
- La qualificazione dell’autore del reato (reato comune o reato proprio?)
- L’elemento soggettivo (dolo specifico)
- L’elemento oggettivo (diffondere notizie su una persona)
- Il pericolo di lesione del bene (lesione della vita o del patrimonio)
- La sanzione (reclusione e una somma di denaro).
Per definire la qualificazione dell’autore e l’elemento soggettivo serviamoci di un reato che ha, su questi due punti, caratteristiche analoghe: il furto. In Italia e poi in Svizzera:
«Furto – Chiunque s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516.»
(Art. 624 CP IT)
«Furto – Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sottrae al fine di appropriarsene una cosa mobile altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.»
(Art. 139 CP CH)
| Legga anche: >Terminologia e metodo: i disastri del trasporto |
In entrambi i codici, quello svizzero e quello italiano, l’autore di reato comune è designato con chiunque. Si tratta di un elemento descrittivo rigido, che non ammette elasticità d’interpretazione. Entrambi gli articoli, poi, definiscono l’elemento soggettivo, il dolo specifico, utilizzando la formula «al fine di…»
L’elemento oggettivo: la condotta
Passiamo ora all’elemento oggettivo del reato che stiamo analizzando: la pubblicazione di notizie relative alla vita di una persona. Vediamo, ad esempio, quali formulazioni utilizza il reato italiano di Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l’ordine pubblico, art. 656 CP (IT). Si tratta, anche in questo caso, di un reato comune e di pericolo:
«Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l’ordine pubblico – Chiunque pubblica o diffonde notizie false, esagerate o tendenziose, per le quali possa essere turbato l’ordine pubblico, è punito se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 309.»
(Art. 656 CP)
Interessante per noi anche l’articolo 615bis CP (IT):
«Interferenze illecite nella vita privata – Chiunque, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata […] è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.»
(Art. 615bis CP)
| Legga anche: >Come tradurre le fattispecie sconosciute |
Vediamo ora com’è formulata la messa in pericolo della vita, dell’integrità di una persona o dell’incolumità pubblica, ad esempio in Svizzera, con l’articolo 129 CP (CH):
«Esposizione a pericolo della vita altrui – Chiunque mette senza scrupoli in pericolo imminente la vita altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. […]»
(Art. 129 CP)
Oppure in Italia con l’art. 423 CP (IT):
«Incendio – Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni. La disposizione precedente si applica anche nel caso d’incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per l’incolumità pubblica.»
(Art. 423 CP)
La scelta fra le diverse formulazioni e le diverse fonti
Troviamo diverse formulazioni: «esporre a pericolo,» «derivare pericolo per…» (o, in altri reati, «porre in pericolo»). Nel nostro testo d’origine, il termine beni si riferisce alle proprietà della persona offesa. Nella traduzione preferiremo perciò il termine patrimonio, che definisce l’oggetto di tutte le condotte che ledono gli averi di un individuo; è anche il titolo di una precisa categoria di violazioni penali, i «reati contro il patrimonio.»
Per quanto riguarda la sanzione, è necessaria un’annotazione importante. L’articolo penale francese, se tradotto alla lettera, recita: «[…] è punito con la reclusione di tre anni e con un’ammenda di 45 000 euro.» Di fronte a questa formulazione suona un campanello d’allarme: è possibile che il codice indichi una sanzione fissa, togliendo al giudice ogni discrezionalità nella commisurazione di essa e perciò violando il principio di proporzionalità della pena?
Il dubbio si risolve sapendo che il codice penale francese ha rinunciato a indicare le pene minime e massime. Con l’ultima riforma, l’unica sanzione indicata è quella massima. E’ lasciato al giudice comminare una pena inferiore, senza limiti verso il basso, ma con l’obbligo di motivare adeguatamente la sua decisione (Cfr. Salvage Ph. – >Droit pénal général – La mesure des peines en cas d’infraction unique, Presses universitaires de Grenoble, 2016).
Siamo di fronte a un caso in cui la conoscenza del diritto sostanziale e procedurale ha conseguenze dirette sulle scelte di traduzione. La resa letterale, infatti, comunica al lettore che la sanzione è di tre anni e 45 000 euro. Il lettore tecnico che conosce la procedura penale francese comprenderà da solo che si tratta di limiti massimi. Tuttavia, il lettore non esperto quasi certamente fraintenderà. Questa parte dovrebbe perciò essere tradotta in modo da comunicare l’informazione corretta, pur discostandosi dalla lettera: «[…] è punito con la reclusione sino a tre anni e con un’ammenda sino a 45 000 euro.»
| Legga anche: >Il linguaggio penale delle epidemie |
Tradurre una fattispecie penale nuova: il risultato
Paragoniamo ora la prima traduzione, nella quale eravamo rimasti aderenti alla lettera del testo francese, con quella che deriva dalle nostre successive considerazioni. Rileggiamo prima l’originale:
«Testo d’origine – Le fait de révéler, diffuser ou transmettre, par quelque moyen que ce soit, des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d’une personne permettant de l’identifier ou de la localiser, dans le but de l’exposer, elle ou les membres de sa famille, à un risque immédiat d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique, ou aux biens, est puni de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.»
Prima traduzione
Il fatto di rivelare, diffondere o trasmettere con qualunque mezzo informazioni relative alla vita privata, familiare o professionale di una persona che permettano di identificarla o localizzarla, allo scopo di esporre la persona stessa o i componenti della sua famiglia al rischio immediato di offesa alla vita o all’integrità fisica o psichica o ai suoi beni, è punito con la reclusione di tre anni e con un’ammenda di 45 000 euro.
Seconda traduzione
Chiunque riveli, diffonda o trasmetta mediante qualunque strumento informazioni attinenti alla vita privata, familiare o professionale di una persona che permettano di identificala o localizzarla, al fine di esporre a pericolo immediato la vita, l’integrità fisica o psichica o il patrimonio della persona stessa o dei suoi familiari, è punito con la reclusione sino a tre anni e con una multa sino a 45 000 euro.
Tradurremo amende con multa, non con il falso amico ammenda. Per la disciplina italiana, infatti, l’ammenda punisce i reati di minor gravità, qui ci troviamo nell’ambito di applicazione di una multa. Lo stesso deve dirsi per la disciplina svizzera, che non conosce il termine ammenda, distingue semmai tra multa penale e multa amministrativa. Il termine è comunque utilizzato solo per utilità di comprensione, poiché l’istituto della multa, in Svizzera, è riservato a reati minori e non può superare l’importo di 10 000 franchi. L’utilizzo del termine alternativo «pena pecuniaria» comporterebbe altri rischi di fraintendimento, poiché generalmente riferito alla conversione di pene detentive. L’uso è del tutto proprio in Italia, invece, dove la multa può essere comminata anche per reati di una certa entità ed elevarsi fino a 50 000 EUR.
| Legga anche: >Termine «crudeltà» e traduzione giuridica |
Dalla fattispecie penale nuova alla traduzione: conclusioni
Abbiamo ottenuto da uno stesso testo due traduzioni estreme: l’una totalmente aderente al testo d’origine, l’altra poggiante sull’analisi degli elementi costitutivi del reato e adattata all’idiomatica dei codici in lingua italiana, a costo di scostarci alquanto dal dettato originale. Fatti salvi i principi inderogabili, a chi traduce il compito di trovare, dove necessario, le giuste mediazioni, tenendo conto degli usi italiani o svizzeri, della tipologia di lettore e degli abituali parametri che ogni professionista ben conosce per garantire l’efficacia del testo secondo la sua destinazione d’uso.
Ciò che importa, qui, è il metodo di lavoro. Dinanzi a una fattispecie penale nuova, per individuare le formulazioni con le quali ricostituirla in una lingua diversa abbiamo «smontato» il reato nei suoi elementi costitutivi e negli aspetti di dottrina. Non abbiamo a disposizione riferimenti giurisprudenziali, poiché la norma è appena nata: potrebbe essere interessante, ad esempio, capire le differenze d’interpretazione giudiziale dell’aggettivo immediato (o imminente in Svizzera) nell’espressione «pericolo immediato» in riferimento specifico a questa nuova legge (potremmo però riferirci, dove opportuno, alla giurisprudenza su fattispecie simili).
Su queste basi abbiamo ricercato le espressioni che comunicano il contenuto nel modo più possibile chiaro e giuridicamente univoco, coerente anche dal punto vista idiomatico. Senza questi passaggi, il rischio di indeterminatezza della traduzione, perciò della sua inefficacia ai fini di un utilizzo tecnico e professionale del testo, resterebbe molto elevato.
| Sugli aspetti metodologici della traduzione giuridica è disponibile il seminario «Il metodo della traduzione giuridica: perché è diverso da tutti gli altri» – Dettagli e iscrizioni qui.
(Articolo pubblicato in originale il 16.12.2020, ripubblicato con aggiornamenti il 24.6.2024)


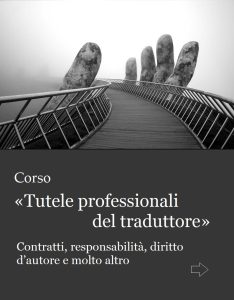
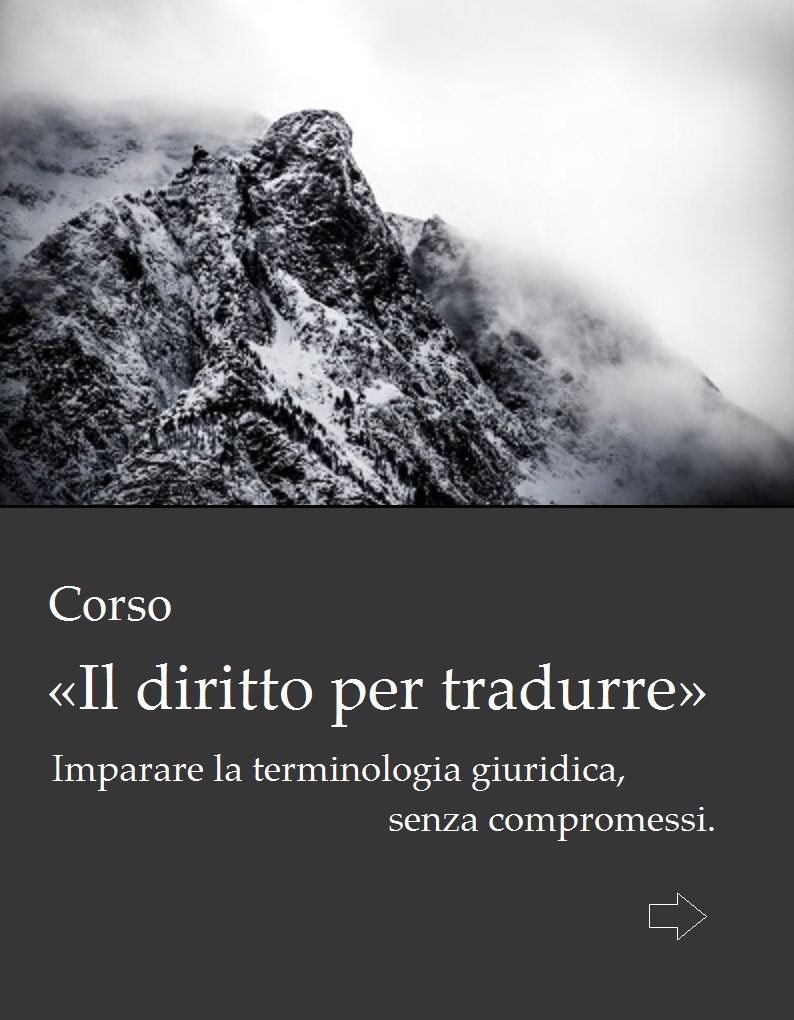

Basilio Buffoni says:
Anche se non ho mai fatto il traduttore di testi giuridici, trovo l’articolo molto interessante; una considerazione: è citato il diritto penale svizzero; mi pare che possa essere molto interessante considerando che immagino il codice penale svizzero esista sia in italiano che in francese, oltre che in tedesco, fornendo così riferimenti che mi sembrerebbero preziosi; mi sembra tuttavia che l’articolo non faccia mai riferimento in questo senso al diritto svizzero; c’è un motivo per questo?
Luca Lovisolo says:
Buongiorno,
Vero, il diritto svizzero è codificato parallelamente in tutte le tre lingue nazionali, parzialmente anche in romancio e in inglese. Tuttavia, i miei articoli, come i miei corsi, si rivolgono a traduttori che lavorano da e verso la lingua italiana. Evito riferimenti ad altre lingue ufficiali svizzere, poiché ciò escluderebbe coloro che non le conoscono, mentre l’italiano è la lingua unificante di chi segue questo blog e le mie lezioni. Cordiali saluti. LL