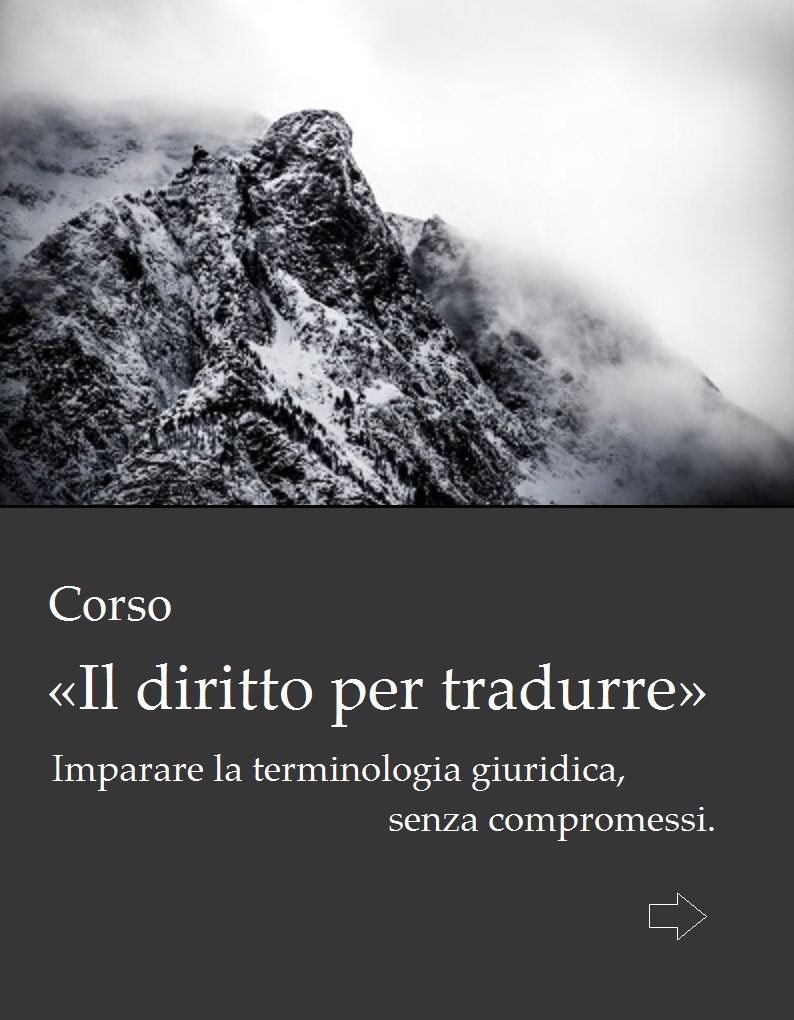In una traduzione giuridica non si dovrebbero introdurre termini che non esistono nell’ordinamento del Paese di destinazione. Nella realtà, talvolta è inevitabile, tradurre istituti e fattispecie sconosciute nell’ordinamento di destinazione. E’ richiesta l’analisi del testo combinata alla sensibilità tipica del traduttore. Alcuni esempi concreti. Alcuni esempi e suggerimenti.
In un precedente articolo (>qui) abbiamo analizzato il caso di fattispecie giuridiche simili ma definite con terminologie diverse tra due ordinamenti, oppure iscritte nei codici con titoli che possono trarre in inganno, ma analoghe nella sostanza e presenti in entrambi i Paesi. Un altro contributo (>qui) è dedicato al caso della traduzione di una norma penale nuova, per la quale non si trovano riferimenti precedenti.
Ci occupiamo qui di un caso simile a quest’ultimo, che nasce però da una situazione diversa. Dove trovare le fonti terminologiche, se nel testo d’origine troviamo una fattispecie non nuova nell’ordinamento da cui proviene il testo, ma sconosciuta nel Paese in cui si parla la lingua verso la quale stiamo traducendo?
| Legga anche: >La traduzione di una norma penale nuova |
Di principio, in una traduzione non si dovrebbero introdurre termini che non esistono nell’ordinamento del Paese di destinazione, perciò non corrispondono a una fattispecie o a un istituto giuridico determinati. Lo scopo è mantenere l’univocità del testo, per evitare confusioni. Di regola, nel linguaggio giuridico, ogni vocabolo ha un solo significato; le eccezioni esistono, ma sono ben riconoscibili.
Tradurre una fattispecie sconosciuta: i termini estranei
Nella realtà, accade di utilizzare termini estranei all’ordinamento a cui è destinata la traduzione. Avviene, ad esempio, quando un certo istituto giuridico esiste nel Paese d’origine ma è sconosciuto in quello di destinazione. In questi casi non vi sono ricette sempre valide. E’ richiesta l’analisi del testo combinata alla sensibilità tipica del traduttore e alla conoscenza dei due ordinamenti. I metodi possono essere molteplici.
Alcuni termini non esistono ufficialmente in un ordinamento, ma i lettori possono comprenderli. Per restare all’interno della lingua italiana, un esempio può essere il termine residente. Nell’ordinamento svizzero non corrisponde a una specifica fattispecie: lo status del cittadino residente corrisponde più da vicino a quello che nella Svizzera italiana si definisce domiciliato (questo, a sua volta, ha in Italia un significato diverso).
Tuttavia, l’uso del termine residente è assai diffuso nel linguaggio comune anche in Svizzera e il suo senso è chiaro: una persona che vive stabilmente in un certo luogo e vi è registrata all’anagrafe (in Italia) o Ufficio controllo abitanti (in Svizzera). Poiché, d’altra parte, in Svizzera residente non evoca una fattispecie determinata, non si rischia il fraintendimento con altre situazioni. Se un termine che non ha una precisa corrispondenza tra Paese di origine e Paese di destinazione non può essere sostituito o spiegato, ma non rischia di causare equivoci, lo si userà comunque, se è ragionevole che il lettore lo comprenda.
| Legga anche: >Linguaggio giuridico e traduzione |
Termini a rischio di incomprensione e fraintendimento
In altri casi è meno immediato, stabilire come tradurre una fattispecie sconosciuta nell’ordinamento di destinazione. Un termine estraneo può essere incomprensibile o fuorviante, a differenza del caso precedente.
Prendiamo l’esempio dell’inglese Public Company. Si tratta di una particolare società per azioni con un azionariato molto diffuso: un gran numero di azionisti possiede poche azioni, perciò una minima quota di capitale pro capite. Per questo, la società è contraddistinta da alcune particolarità organizzative. Negli ordinamenti giuridici dei Paesi continentali esistono la Società per azioni (S.p.A., in Italia), la Società anonima (SA, in Svizzera), la Aktiengesellschaft (AG, nei Paesi di lingua tedesca). Non si pratica, però, una differenziazione tra azionariato più o meno diffuso.
Una traduzione letterale di Public Company con «Società pubblica» (purtroppo non è raro sentirla) non comunica al lettore il senso originario e può essere fraintesa come impresa o altro organismo di diritto pubblico, cioè controllato dallo Stato e funzionante secondo la disciplina pubblica. La Public Company, invece, è una società di diritto privato e l’aggettivo public si riferisce alla massificazione degli azionisti, non al diritto che la governa.
| Legga anche: >Come tradurre succursale, filiale, gruppo… |
Quando e se riportare i termini senza tradurli
In questi casi può essere utile riportare il termine senza tradurlo, se ci si può attendere che i destinatari lo comprendano. Restando nell’esempio, i lettori esperti, anche fuori dallo spazio linguistico inglese, sanno cos’è una Public Company, i meno esperti forse no. Esiste la traduzione Società ad azionariato diffuso, che non corrisponde a una forma giuridica societaria degli ordinamenti di lingua italiana, ma può essere compresa più largamente ed evita la confusione con gli enti di diritto pubblico.
In altri casi si può spiegare brevemente il termine in parentesi quadre o in una nota a pie’ di pagina. Il crinale sul quale si cammina è molto stretto: occorre individuare un termine che sia chiaro al lettore, ma non induca in confusione con altri istituti o fattispecie del Paese di destinazione.
Anche in questi frangenti, perciò, la conoscenza dell’ordinamento è l’appiglio che evita di scivolare su fastidiose bucce di banana. E’ di fronte a queste scelte che emerge la capacità del traduttore di garantire in ogni singola situazione la buona comunicazione tra lingue e Paesi diversi.
| Sugli aspetti metodologici della traduzione giuridica è disponibile il seminario «Il metodo della traduzione giuridica: perché è diverso da tutti gli altri» – Dettagli e iscrizioni qui.
(Articolo pubblicato in originale il 11.2.2019, ripubblicato con aggiornamenti il 26.7.2024)