
Chi era e cosa faceva Aleksej Naval’nyj, l’attivista russo più noto anche in Occidente. Era davvero il leader dell’opposizione? La sua morte in un penitenziario siberiano fa ripercorrere la sua storia. I processi e l’avvelenamento. Più chiaro il suo profilo di attivista, meno quello politico. Il contesto in cui agisce l’opposizione russa oggi. Il rigore del regime, accresciuto con la ripresa della guerra in Ucraina.
Ucciso o lasciato morire in una colonia penale sperduta nella Siberia settentrionale, dove le temperature sono così basse che la nostra immaginazione fatica a figurarsele, secondo quanto hanno comunicato il 16 febbraio gli organi competenti russi è deceduto per cause che mai saranno accertate Aleksej Anatolevič Naval’nyj, di anni 47, il più celebre ed efficace oppositore al regime di Vladimir Putin. Naval’nyj era una figura carismatica dell’opposizione russa, ma l’immagine di lui che si è consolidata in Occidente non gli corrisponde del tutto. Proviamo, in queste righe, a spiegare chi era Aleksej Naval’nyj e cosa faceva.
Cominciamo con qualche informazione sulla >sua vita e sulle vicende processuali; ripercorriamo in breve la cronaca del >tentativo di avvelenamento; chiediamoci poi se Naval’nyj era davvero il >leader dell’opposizione russa. Diamo uno sguardo alla >società russa a cui parlano i politici di Mosca e osserviamo >quali prospettive ha oggi l’opposizione al Cremlino. Concludiamo con alcune considerazioni sul >significato della vicenda Naval’nyj anche per noi, in Occidente
ALEKSEJ NAVAL’NYJ: CHI ERA E CHE COSA FACEVA
Aleksej Anatol’evič Naval’nyj, avvocato, non era un politico in senso proprio. Nato nel 1976 a Butyn’, presso Mosca, era diventato popolare grazie a Internet, come direttore del suo centro d’inchiesta contro la corruzione Fond bor’by s korrupciej («Fondazione per la lotta contro la corruzione»). Il centro, oggi chiuso per decisione giudiziaria, contava molti motivati cooperatori, tra i quali l’avvocatessa Ljubov’ Sobol’, il già viceministro russo per l’energia Vladimir Milov e molti altri. Tutti i dirigenti della fondazione erano regolarmente fatti segno di ordini di fermo, perquisizioni e altre misure di polizia difficili da motivare, secondo i criteri di uno Stato di diritto.
Le rivelazioni della fondazione di Naval’nyj non inquietavano solo la scena politica, ma anche l’oscuro panorama degli oligarchi russi. Nel 2017 Naval’nyj aveva pubblicato un video (>qui) con riferimenti a numerosi immobili che sarebbero proprietà dell’allora primo ministro russo Dmitrij Medvedev, pur se intestati a prestanome. Tra di essi vi sarebbe una grandiosa villa in Toscana. Un video di grande successo è uscito nel 2021, raggiungendo in poche ore milioni di visualizzazioni (>qui). Ha per oggetto un enorme podere sulle rive del Mar Nero, all’interno del quale si trova un pomposo edificio di lusso. Secondo quanto affermano gli autori dell’inchiesta, il fondo sarebbe una proprietà di Vladimir Putin, mascherata intestandola a parenti e persone della sua cerchia più ristretta.
| Legga anche: >Di cosa si lamentano i russi con Putin |
Chi era e cosa faceva Naval’nyj: i processi politici e le condanne
Poche altre cose definiscono chi era e cosa faceva Naval’nyj, però, come i processi a cui è stato sottoposto, con evidenti pretesti politici. I reati contestatigli includono la truffa aggravata (art. 159 cpv. 1-2 CP RU), l’oltraggio al magistrato in udienza (art. 297 cpv. 2 CP RU), l’offesa a un veterano di guerra (art. 128.1 CP RU vecchia versione), sino alla recente condanna per costituzione di un’organizzazione estremista (art. 282.2 CP RU). Le manifestazioni alle quali chiamava i suoi sostenitori non venivano mai autorizzate dalle autorità. Per questo Naval’nyj subiva continui provvedimenti di fermo e arresto per violazione delle poco generose norme russe sul diritto di manifestazione. Il comportamento della giustizia russa verso l’attivista è stato stigmatizzato nel 2017 e nel 2018 dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo, perché politicamente fazioso. I processi in Russia contro Naval’nyj erano spesso oggetto di proteste e battibecchi diplomatici fra Russia e Occidente.
Chi era e cosa faceva Naval’nyj lo sapeva meglio di tutti la generazione dei russi più giovani, nelle grandi città. Naval’nyj non aveva accesso ai media ufficiali. Cosa avrebbe fatto, se fosse salito al vertice dello Stato russo, nessuno ha mai saputo dirlo con esattezza. Ho parlato con dei russi che certamente non sostenevano Putin, ma guardavano con terrore a un eventuale governo Naval’nyj. Tutto ciò premesso, mettere a tacere Naval’nyj era fermamente nell’interesse del regime russo e degli affaristi che circondano il Cremlino, in gran parte oligarchi di prima e seconda generazione che sostengono il sistema-Putin con fedeltà incrollabile e ne ricevono generose contropartite. Tutti sapevano benissimo chi era e cosa faceva Naval’nyj. L’ultimo tentativo di ucciderlo è stato l’avvelenamento avvenuto nel 2020, che ha avuto risonanza internazionale. Merita ripercorrerne la cronaca.
NAVAL’NYJ, CHI ERA COSA FACEVA: L’AVVELENAMENTO
Il 20 agosto 2020 l’aereo di linea sul quale Aleksej Naval’nyj vola da Tomsk a Mosca è costretto a un atterraggio di emergenza. Naval’nyj si sente male e viene ricoverato nell’ospedale della città di Omsk, privo di conoscenza e con i sintomi di un pesante avvelenamento. Per curarlo e chiarire le circostanze del suo malore la famiglia e alcuni politici occidentali insistono affinché sia trasferito in Germania. L’accaduto ricorda il caso di un altro critico del regime russo, Pëtr Verzilov: nel 2008 era stato vittima anch’egli di un evento simile, con sintomi analoghi. Era stato curato all’ospedale della Charité, a Berlino, dov’era guarito dopo mesi di trattamenti.
| Legga anche: >Cinque perché l’Italia vuole servire la Russia |
Sul caso Naval’nyj cala la cortina fumogena del regime russo. Il 21 agosto i medici di Omsk dichiarano che nel paziente non è stata rinvenuta alcuna traccia di sostanze velenose. L’affermazione dei clinici russi non convince: parlano in presenza di uomini sconosciuti, in abito civile e con la mascherina alla bocca; la funzione di questi accompagnatori non è chiara, ma certamente non appartengono al personale dell’ospedale. Si rafforza il sospetto che i medici stiano trattando il caso Naval’nyj sotto diretta sorveglianza dei servizi segreti.
Il trasferimento e la guarigione in Germania
Le autorità di Mosca rifiutano dapprima il trasferimento del paziente in Occidente. Il 22 agosto Naval’nyj viene finalmente ricoverato nell’ospedale berlinese della Charité. Il 24 agosto i medici tedeschi comunicano che Naval’nyj non è più in pericolo di vita. Più tardi, il governo tedesco dichiara che nel corpo di Naval’nyj sono state trovate tracce di un veleno appartenente al gruppo di armi chimiche Novičok.
Naval’nyj, pertanto, non è stato vittima di un normale avvelenamento. E’ stato obiettivo di un attentato, attuato impiegando un’arma chimica, disponibile in Russia in dispregio di ogni divieto imposto dai trattati internazionali. Pochi giorni dopo, due altri centri di ricerca, in Svezia e in Francia, confermano la presenza di Novičok nel corpo di Naval’nyj. Il Novičok non si compra al supermercato: è un’arma. Ad avervi accesso è una cerchia relativamente ristretta di persone.
Dopo mesi di cure in Germania, Naval’nyj è salvo. Durante la conferenza stampa di fine d’anno 2020, Putin si esprime sull’avvelenamento di Naval’nyj in modo molto sfrontato. Senza dire né il nome di Naval’nyj, né chi era e cosa aveva fatto, Putin afferma: «Se avessimo voluto avvelenarlo noi avremmo finito il lavoro,» cioè lo avremmo ammazzato senza possibilità di errore. Putin, quando parla, pesa le parole sul bilancino dell’orafo e di solito si esprime in modo piuttosto chiaro. Questa affermazione a proposito di Naval’nyj certamente non è casuale. Con essa, Putin dice senza più freni inibitori che lo Stato può uccidere chi non piace al regime. Naval’nyj ne è uscito vivo, ma tutti gli altri stiano allerta. Si sapeva già, ma ora a dirlo è il capo dello Stato.
| Legga anche: >Russia, tentato colpo di Stato: la spiegazione |
Naval’nyj, chi era e cosa faceva: il ritorno in Russia
Il 17 gennaio 2021 Naval’nyj torna in Russia, guarito. All’aeroporto di Mosca Domodedovo viene fermato al controllo passaporti e condotto nel carcere moscovita della via Matrosskaja Tišina. Sulla base di una sentenza del 2014, il 2 febbraio il tribunale lo condanna a tre anni e mezzo di reclusione. Secondo i giudici, a causa del suo ricovero in ospedale a Berlino non avrebbe rispettato l’obbligo di firma. In conseguenza di questo provvedimento, a cui seguiranno altre due condanne, viene incarcerato e resterà detenuto sino alla morte.
Le manifestazioni che si svolgono in tutta la Russia dopo il rientro di Naval’nyj si distinguono da quelle del periodo precedente il suo avvelenamento sotto diversi aspetti. Il numero dei partecipanti è più elevato che mai. I media di Stato, sino a quel momento, avevano quasi o del tutto ignorato i cortei di Naval’nyj; dopo il suo rientro, invece, i servizi giornalistici sono stranamente esaustivi. Le notizie, però, non vengono introdotte spiegando senso e scopo delle manifestazioni, chi era e cosa faceva Naval’nyj, ma elencando i procedimenti giudiziari pendenti su Naval’nyj stesso. Sul suo avvelenamento, non una parola. Lo scopo evidente è dissuadere i cittadini dal prendere parte alle manifestazioni organizzate dall’oppositore.
I media ufficiali descrivono le manifestazioni come cortei di giovani illusi, vittime dalla propaganda occidentale. Le immagini che scorrono sulle poche reti indipendenti rimaste raccontano un’altra storia, però. Piazza Puškin a Mosca e i vialoni di San Pietroburgo sono neri di una folla di ogni età, mai vista prima. Ai microfoni degli intervistatori, molti cittadini dichiarano di partecipare per la prima volta a una manifestazione. Durante i due fine settimana di protesta vengono arrestati complessivamente circa 9000 dimostranti.
La reazione di Putin
E’ molto istruttivo il modo in cui Vladimir Putin parla delle manifestazioni, in quei giorni, rivolgendosi a un gruppo di studenti universitari. La sua argomentazione è un esempio di come viene distorta la realtà a fini di propaganda. Il presidente russo paragona le proteste in Russia all’assalto al parlamento degli Stati uniti del 6 gennaio 2021, dicendo: in Russia, chiunque è libero di manifestare il proprio pensiero, purché lo faccia nel rispetto della legge. Negli Stati uniti, coloro che hanno assaltato il parlamento sono stati arrestati e rischiano condanne pesantissime, perché hanno manifestato il loro punto di vista, ma lo hanno fatto violando la legge. Anche in Russia, coloro che hanno voluto manifestare in piazza hanno violato la legge, perché le manifestazioni non erano autorizzate, perciò è giusto che siano arrestati e condannati.
| Legga anche: >L’evento che caratterizza questa fine d’anno |
Putin non dice, però, che nessuna manifestazione di protesta contro il regime viene autorizzata, perciò la libertà di espressione che lui vanta non esiste. Inoltre, Putin «dimentica» che gli assalitori del Campidoglio (tra i quali, ironia del destino, si contavano anche cittadini russi) non esprimevano pensieri qualunque: agivano con l’intento esplicito di capovolgere le istituzioni e aggredire fisicamente le più alte autorità dello Stato. In Russia, nelle dimostrazioni organizzate da Naval’nyj, ciò non accadeva e i casi di vandalismo o violenza erano del tutto sporadici.

NAVAL’NYJ, CHI ERA E COSA FACEVA: LEADER DELL’OPPOSIZIONE?
Si può ammirare Naval’nyj per il suo coraggio civile e per il suo talento organizzativo, ma i contorni del suo programma politico sono rimasti molto incerti. Il suo partito, Rossija Buduščego («La Russia del futuro»), si è sempre visto rifiutare la registrazione ufficiale da parte delle autorità. Attribuire a Naval’nyj una visione del mondo all’occidentale, nel senso di una società aperta, sembra affrettato. Alcune sue affermazioni sulla guerra in Georgia e sulla crisi ucraina hanno suscitato molti interrogativi, come le sue prese di posizione sui conflitti etnici nello spazio ex sovietico. All’inizio della sua carriera, come membro del partito Jabloko («La mela»), Naval’nyj si presentava come politico liberale. Negli anni successivi è parso portare maggiore attenzione verso gli strati più svantaggiati della società russa.
Oggi, alla sua morte, in Occidente Naval’nyj è ricordato come «leader dell’opposizione russa.» La realtà è più cruda. Un tale leader, in Russia, non esiste, perché non esiste nemmeno una vera opposizione. La situazione è ancora peggiorata dopo la ripresa della guerra in Ucraina, il 24 febbraio 2022. Gli avversari del Cremlino formano una galassia di blogger, attivisti e commentatori che non fanno massa critica, presi singolarmente. Liberi ma inefficaci, se fuggiti all’estero; incarcerati o morti, se rimasti in Russia.
Naval’nyj, tra tutti, era di gran lunga quello più organizzato e di maggior successo, ma non aveva intorno a sé una vera struttura politica, come non l’hanno gli altri attivisti antiregime russi fuori dal parlamento. Un’opposizione all’interno del parlamento esiste, a Mosca, ma non può contraddire nell’essenziale la linea del partito di Putin, Edinaja Rossija («Russia unita»). I partiti di opposizione parlamentare, per il regime di Mosca, fungono più da stampelle che da vere controparti politiche.
| Legga anche: >Michail Gorbačëv: cosa ha fatto e cosa ci lascia |
Cosa faceva? Distinguere l’attivista dal politico
In breve: tra il Naval’nyj attivista e il Naval’nyj politico bisogna tracciare un confine. Sul terreno dell’attivismo, i contorni della sua opera sono definiti; su quello della politica, è più difficile dire chi era e cosa faceva. Per classificare la sua azione, le vecchie categorie del pensiero politico – destra/sinistra, progressista/conservatore – aiutano poco o niente.
Il suo messaggio aveva un innegabile tratto nazionalista, ma il suo zigzagare ha sempre impedito di tracciare di Naval’nyj un profilo politico preciso, al di là dei paroloni buttati a casaccio dalla propaganda, sia in Russia sia in Occidente. Le accuse di neofascismo o neonazismo, che ormai non si negano a nessuno, rivolte a Naval’nyj sono esagerazioni frutto di ignoranza e pregiudizio. L’aggettivo «liberale,» spesso usato per definire gli oppositori a Putin, ha in Russia un significato piuttosto diverso da quello che gli diamo noi. In un regime di fatto a partito unico, queste incertezze di posizionamento, però, non devono stupire.

LA RUSSIA DI PUTIN E QUELLA DI NAVAL’NYJ
Per capire chi era e cosa faceva Aleksej Naval’nyj nella Russia di Putin bisogna conoscere la società a cui parlano i politici russi, Putin in particolare. I discorsi del presidente russo hanno un destinatario-tipo ben definito. Si rivolgono ai russi, maggioritari, che vivono fuori dalle grandi città, paghi della loro vita e del loro orizzonte che finisce dove passa il confine del loro villaggio. Non hanno connessione Internet, non parlano inglese; quando rispondono alle domande di qualche viaggiatore o giornalista che si inoltra in quelle lande dicono tutti più o meno la stessa cosa: la pensione arriva, qui abbiamo aria pura e acqua pulita, cosa bisogna volere di più dalla vita?
| Legga anche: >Dugin è davvero ideologo di Putin? Sì, no, perché |
Per noi occidentali è molto difficile figurarci lo spazio fuori dalle grandi città, in Russia e in buona parte dell’Europa orientale. Da noi, ormai, la differenza tra città e campagne è pressoché nulla, grazie a uno sviluppo economico più equilibrato, particolarmente dal Dopoguerra in poi. L’economia urbana e quella rurale sono integrate. A est, invece, la popolazione delle campagne resta legata a una sorta di economia agricola di sussistenza: gli abitanti producono da soli il loro fabbisogno alimentare e guadagnano il poco denaro necessario per il resto dei servizi attraverso la vendita del sovrappiù o facendo qualche lavoro stagionale.
I serbatoi di voti per Putin nella Russia profonda
La vita nella campagna russa è un circuito socioeconomico a sé. Piacerebbe a molti cultori della vita romantica e della decrescita felice, ma si porta appresso pesanti limitazioni alle possibilità di sviluppo personale, di istruzione e di comunicazione con il resto del mondo. Persino la lingua è diversa: in Russia non esistono i dialetti, come li intendiamo noi, la parlata si differenzia tra città e campagne. Nei casi più estremi i russi delle città faticano a capire i campagnoli, che non aprono le o, troncano le terminazioni degli aggettivi e impastano le consonanti. C’è una definizione specifica, carica di storia, per quel modo di parlare: kolchoznoe proiznošenie, «pronuncia da kolchoz,» le cooperative agricole collettivizzate del periodo sovietico.
La separazione tra città e campagne ha radici storiche profonde. I contadini dei kolchoz – che rappresentavano quasi il 40% della popolazione sovietica – non avevano nemmeno diritto di ricevere la carta d’identità. Venivano iscritti nei registri della cooperativa agricola al compimento dei 16 anni d’età e non potevano allontanarsene senza il permesso del comitato che la amministrava. Ciò impediva loro, tra l’altro, di cercare liberamente prospettive di vita o un lavoro diverso nelle città. I contadini dei kolchoz poterono a ricevere i documenti d’identità solo a partire dal 28 agosto 1974. Non è raro, in russo, sentir usare ancora oggi l’espressione «venire dalla campagna» con tono dispregiativo, più o meno ironico, per indicare arretratezza, ignoranza, ingenuità.
A questa categoria di cittadini, si rivolgono gli autocrati dell’Est, non solo in Russia. Nell’agosto 2020, quando in Bielorussia cominciarono a prendere corpo manifestazioni di protesta contro il regime, Aljaksandr Lukašenka organizzò centinaia di autobus per andare a prelevare gli abitanti delle campagne e portarli a sfilare nella capitale a favore del suo regime, immobile da trent’anni. Lo stesso vale per i partiti ultraconservatori e cattolici di Polonia, Ungheria e altri Paesi dell’Est. E’ nelle campagne, che hanno i loro inesauribili serbatoi di voti.
La nostalgia dei bei tempi andati
Il tipo umano russo di cui stiamo parlando non è rappresentato solo da contadini in senso stretto. E’ onnipresente, tra le popolazioni della provincia russa, rintanate nelle scolorite periferie delle città, intabarrate nei loro paltò e nelle loro ušanka (quello che noi chiamiamo «colbacco»), ma egualmente disinteressate a ogni sviluppo.
Se gli ospedali chiudono, se dai tetti delle scuole piove dentro, se le strade sono un pantano, per questa parte di popolazione la colpa non è di Putin, ma del crollo dell’Unione sovietica e del comunismo, che a tutto provvedeva; oppure, è colpa «dell’Occidente,» che odia e aggredisce la Russia. Putin, ai loro occhi, è l’uomo che tenta di riconquistare la grandezza perduta, che si oppone alla «aggressione» dell’Occidente in Ucraina, e fustiga i governatori delle regioni, quando, durante le interminabili dirette televisive del presidente, gli abitanti delle province lamentano che manca il necessario.
Molti russi che la pensano così, in realtà, per ragioni di età non hanno conosciuto il periodo sovietico, se non nella prima gioventù o attraverso i ricordi dei genitori. La loro nostalgia e la loro diffidenza verso l’Occidente sono frutto della propaganda, che funziona brillantemente, su persone che non vedono altro se non la TV di Stato. Per leggere e ascoltare i pochi media alternativi rimasti e i canali internazionali, serve una tecnologia che loro non sanno usare. La ripresa della guerra in Ucraina ha rafforzato questo atteggiamento, sfruttato a fondo dai media di Stato.
Chi altri sostiene gli autocrati dell’Est?
A questa popolazione, la logica elementare dei discorsi di Vladimir Putin si adatta alla perfezione. E’ il ritratto del cittadino che esce dalla Quarta teoria politica di Aleksandr Dugin. Se non arriva la politica, a catturare questa fascia di cittadini, ci arriva la Chiesa ortodossa con i suoi predicatori dalle lunghe barbe. Il risultato non cambia.
L’altra categoria alla quale si rivolgono i satrapi dell’Est è quella dei funzionari dello Stato. Questi avversano ogni cambiamento, perché sanno che la caduta del regime significherebbe la loro epurazione. Se Putin o Lukašenka danno risposte che non convincono, lo capiscono ma sorvolano, perché sanno che i capi del regime, con i loro fervorini, proteggono non solo se stessi, ma anche il sistema di potere del piccolo impiegato pubblico. Per non parlare degli oligarchi, i ricchi sfondati del postcomunismo, che oscillano in una nube grigia tra politica ed economia sommersa.
Poi c’è la massa degli indifferenti, non ignoranti ma nemmeno colti, non isolati ma nemmeno aperti al mondo, non contadini ma nemmeno del tutto urbanizzati. Forse non sostengono Putin, ma non lo avversano. Quando parli loro di politica, ti dicono: e se non voto Putin, chi altro voto? Del resto, al mondo non si può pretendere che tutti siano dei cuor di leone.
| Legga anche: >Il Museo Roerich di Mosca oggi: Stato pietoso |
NAVAL’NYJ, CHI ERA E COSA FACEVA: QUALE OPPOSIZIONE OGGI?
Si pensava che l’avvelenamento di Naval’nyj e il suo rientro in Russia dopo la guarigione avrebbero segnato un giro di boa, per l’opposizione. Non è stato così. Il giornalista tedesco Peter Tiede sapeva bene chi era e cosa faceva Naval’nyj, lo aveva intervistato più volte ed era con lui sul volo verso Mosca. Racconta che Naval’nyj era pienamente consapevole che tornare in Russia avrebbe significato il carcere e forse la morte. L’arresto, appena messo piede in aeroporto, i nuovi processi e l’ultima condanna hanno chiuso con la morte la sua straordinaria parabola di attivismo. Quasi in parallelo con le ultime vicende giudiziarie di Naval’nyj, la guerra in Ucraina ha stretto ulteriormente le già anguste maglie del controllo politico sul Paese.
Gli unici che possono scuotere la Russia (e altri Paesi dell’Est) dal loro galleggiamento nel surreale sono gli abitanti più istruiti, in prevalenza giovani e giovani-adulti, concentrati nelle grandi città, che parlano le lingue, si informano via Internet e viaggiano all’estero. Sono – in parte, non tutti – quelli ai quali si rivolgeva Naval’nyj, che sapevano chi era e cosa faceva. Quelli che scendevano in piazza con lui e che oggi sfidano le forze dell’ordine per deporre fiori in sua memoria. Sono pochi, però, anche se nelle strade di Mosca e San Pietroburgo sembrano tanti, e oggi sono fuggiti in gran numero all’estero. Se anche si sommano i partecipanti a tutte le manifestazioni organizzate da Naval’nyj, i simpatizzanti che strizzano l’occhio ma non osano scendere in piazza, i seguaci di varia natura, che sapevano chi era Naval’nyj e apprezzavano cosa faceva, si ottengono numeri minimi.
Varcare i confini delle minoranze
Se questa minoranza attiva non riesce a smuovere la maggioranza, inerte e non ancora abbastanza insoddisfatta dello status quo, il regime non avrà motivo di temere per le sue poltrone. La piramide del potere del partito di Putin è ben salda. Quelli che ne ricavano il proprio pezzettino di fortuna prevalgono ancora su quelli che ne soffrono la prepotenza. Le conseguenze della guerra in Ucraina sembra stiano smuovendo qualcosa, anche nelle regioni più discoste, ma è presto per dire.
Oggi, tutti gli oppositori al regime di Putin piangono la scomparsa di Aleksej Naval’nyj, perché tutti riconoscevano la sua autorità morale, oltre gli steccati. Sapevano chi era e cosa faceva. Naval’nyj muore lasciando un successo e un insuccesso: ha segnato la vita pubblica russa con il più efficace movimento di protesta civile dell’era Putin; nonostante il suo carisma, però, non è riuscito a costituire un polo unificante per l’opposizione, malata di inguaribili divisioni e personalismi che la condannano all’insignificanza.
Per conseguire qualche risultato, l’opposizione russa dovrà superare le sue divisioni e raggiungere quelle periferie nelle quali oggi Putin pesca i suoi consensi. Dovrà spezzare il sonno degli indifferenti, dovrà volgere a sé i voti dei funzionari pubblici. Dovrà convincere decine e decine di milioni di russi, anche quelli che ignoravano chi era e cosa faceva Naval’nyj, che uno Stato di diritto ha più vantaggi della terza edizione dello zarismo nella quale oggi vedono marcire i loro diritti fondamentali.
A questo scopo, un’opposizione deve concepire un progetto di sviluppo per tutta le Russia, capace di futuro, da attuare facendo leva su una moderna classe media che operi in un’economia libera e in una società aperta. Queste condizioni-quadro devono prima essere create, poiché in Russia di fatto non esistono.

CHI ERA E COSA FACEVA NAVAL’NYJ, ANCHE PER L’OCCIDENTE
Cosa dicono la vita e la morte di Aleksej Naval’nyj a noi occidentali? Dobbiamo prendere le distanze dal nostro entusiasmo per i cortei di protesta; chiederci se le manifestazioni di massa sono davvero il passo giusto verso un cambiamento, se una società civile russa esiste davvero, dove e in quali forme. La validità dei modelli di pensiero occidentali non si estende senza limiti verso est.
La vicenda di Naval’nyj ha un valore oggettivo, oltre la sua portata soggettiva. Ci mette di fronte all’evidenza che nella Russia di Putin chi non si allinea al governo viene trattato con le armi chimiche, viene zittito applicando il codice penale del regno dell’assurdo e muore in un gelido penitenziario costruito sui resti di un vecchio gulag staliniano. Un Paese in cui una storia secolare di monarchie assolute, totalitarismo e autoritarismo non si concluderà a breve.
Le armi di quel Paese tuonano oggi in Ucraina, cioè in Europa, cioè in casa nostra. Dipende da noi, decidere se cullarci nell’illusione irresponsabile che con un vicino così sia possibile dialogare, trattare, firmare trattati di pace che vengono rispettati. Se la Russia vincerà in Ucraina, la sua storia di autoritarismo busserà col moschetto alle nostre porte. Chi ammicca alla Russia di Putin gioca con i nostri diritti fondamentali, non solo con quelli dei russi.
| Legga anche: >Perché Putin vuole la guerra contro tutti noi |
Sotto la bombe russe in Ucraina sta germogliando un nuovo ordine mondiale nel quale gli Stati autoritari si impongono, in parole ed opere, in modo sempre più sfrontato. Il destino di Aleksej Naval’nyj e dei tanti oppositori russi esiliati, incarcerati o uccisi negli ultimi anni è un’altra triste pagina di un’attualità sempre più spaventosa.
(Articolo pubblicato in originale il 12.2.2021, ripubblicato con aggiornamenti il 19.02.2024)

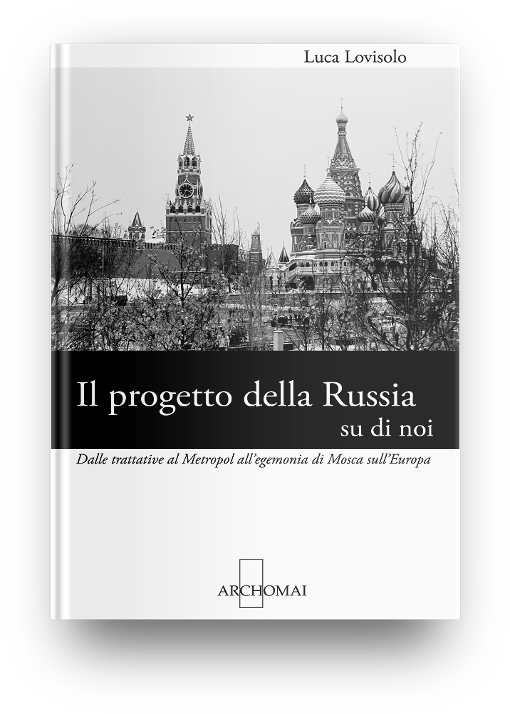
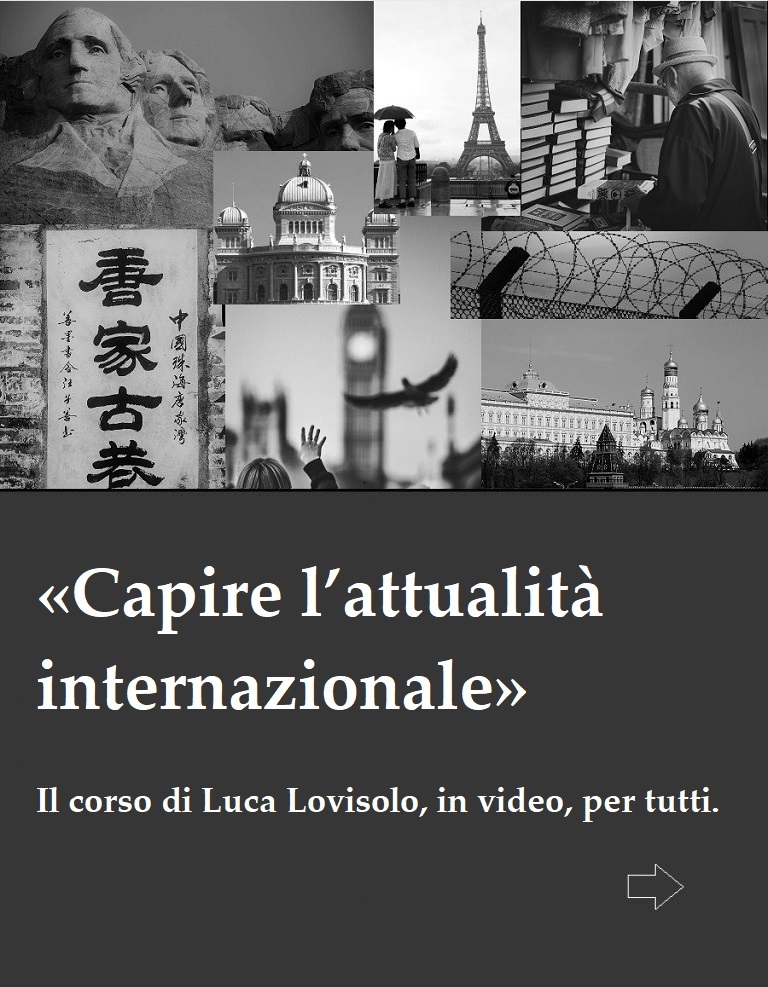

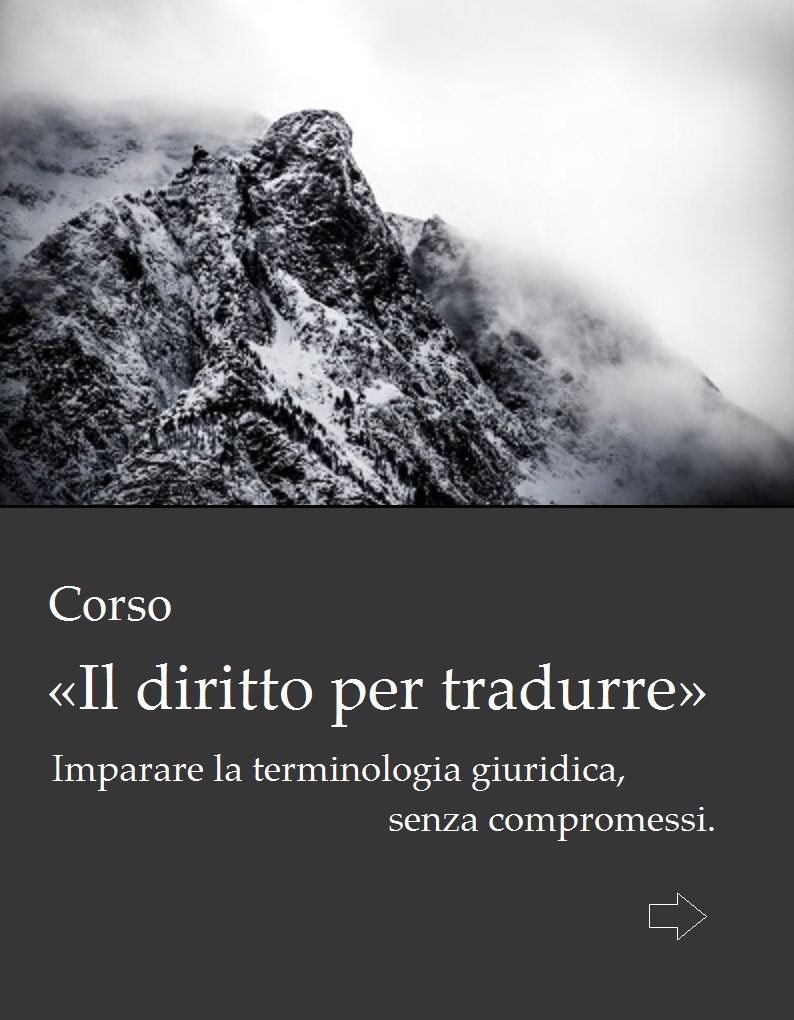

Elena says:
Bell’articolo. Soprattutto perché mette in evidenza il fulcro della questione: il problema culturale.
I sistemi democratici, oltre che sul bilanciamento dei poteri, si reggono anche sulla capacità dei cittadini di valutare criticamente le proposte sulle quali saranno tenuti ad esprimersi alle urne. Purtroppo la nostra legge elettorale è modellata non su un sistema partitico ma leaderistico, dove “il capo” è la figura pubblica che decide, sceglie e governa il suo seguito. In pratica gli italiani danno mandato di rappresentanza a una sola persona. Da qui alla deriva autoritaria il passo è breve. Si aggiunga a ciò il preoccupante abbassamento del livello culturale dei cittadini, che abbandonano gli studi in percentuale molto maggiore rispetto ad altri paesi europei e in compenso leggono molto meno.
Partire da una riforma educativa e culturale è urgente e indispensabile.
Luca Lovisolo says:
E’ vero. Su basi diverse, in Italia si osservano dinamiche simili a quelle in azione in Russia.
Armando Borghi says:
Lei è un professionista eccellente e trovo le sue analisi di grande qualità. Grazie.
Luca Lovisolo says:
Grazie a Lei per l’apprezzamento. LL
Lorenzo says:
Davvero i miei complimenti per questo articolo, sento da amici la critica che era Navalny era di destra… dal suo articolo non risulta, può confermarlo?
Grazie Lorenzo
Luca Lovisolo says:
Come spiego anche nell’articolo, le categorie classiche della politica (destra, sinistra, etc.) servono poco oggi in Russia, anche se in Occidente continuiamo a pretendere di usarle per analizzare quella realtà. Naval’nyj aveva una visione nazionalista, questo forse è l’unico elemento che è emerso in tutta la sua attività politica. Il suo profilo politico è rimasto incerto. Di sicuro non era un neofascista o un estremista, come molti gli rimproverano, senza conoscerne la storia. Non era neppure di sinistra, anche se talvolta sembrava riprendere certi temi sociali. Come altri oppositori a Putin, non era classificabile secondo le definizioni più usuali. Cordiali saluti. LL
Paola says:
Cosa intende quando dice che Navalny era un nazionalista? Che significato ha nel contesto della storia russa?
Luca Lovisolo says:
Buongiorno,
Si intende la tendenza che considera l’etnia russa come avente diritto di supremazia sulle altre, nel complesso delle etnie che popolano la Russia federale di oggi, in precedenze l’Unione sovietica e prima ancora l’Impero russo. L’Impero zarista era una struttura coloniale: a popoli di lingue e culture diverse veniva imposta la matrice russa, come avveniva da parte di Francia, Inghilterra o Spagna verso loro imperi coloniali. La differenza risiedeva nel fatto che gli imperi delle potenze coloniali europee si trovavano in altri continenti, quello della Russia si estendeva nei Paesi confinanti. L’Unione sovietica, dietro la retorica marxista-leninista, fu continuatrice di quel principio, sotto il mantello di un ordinamento federale che in realtà nascondeva uno Stato centralizzato. La Russia di oggi, formata da popoli molto diversi, continua a fondarsi sul principio della supremazia russa rispetto alle altre componenti etniche, appena mitigata da concessioni di autonomia locale poco più che teoriche.
Il nazionalismo russo di Naval’nyj non giungeva agli estremi dei movimenti nostalgici e di estrema destra, che in Russia sono molto forti e hanno fatto risentire la loro voce già negli ultimi anni di vita dell’Unione sovietica. E’ sbagliato, perciò, definire Naval’nyj un neofascista o estremista. Di certo, però, non disprezzava l’idea di supremazia etnica russa e questo è uno degli aspetti più critici della sua opera politica. Per questo motivo non ha mai apertamente criticato la guerra in Ucraina o gli interventi russi volti a ripristinare il controllo di Mosca su regioni ex sovietiche ed ex imperiali. Le sue correzioni di rotta, nel merito, sono state tardive e poco convincenti.
Nell’intervento in cui ha annunciato di proseguire l’attività del marito, anche Julija Navalnaja ha mantenuto la stessa ambiguità, suscitando critiche. Ha poi fatto riferimenti alla guerra in Ucraina nel giorno del secondo anniversario del conflitto e dinanzi al Parlamento europeo, forse consigliata a prendere una posizione più netta. In forme diverse, ma secondo principi analoghi, la supremazia russa anima anche le dottrine eurasiste da cui prendono spunto Aleksandr Dugin e, in conseguenza, Vladimir Putin e la dottrina russa delle relazioni internazionali della Russia postsovietica. Pur combattendo Putin, sotto questi aspetti Naval’nyj non era lontanissimo dalle posizioni del Cremlino. Per questo motivo il giudizio sulla sua opera di politico – che va giudicata distintamente da quella di attivista, come spiego sopra – resta prudente.
Cordiali saluti
LL
Franco Chierici says:
Ho sentito Travaglio parlare di Navalny come persona che odiava i mussulmani ed era fautore della ricostruzione della grande Russia. E’ vero?
Luca Lovisolo says:
Buongiorno. Come ho spiegato nell’articolo e nella risposta al precedente commento, nel profilo politico di Naval’nyj vi erano tratti nazionalisti. Parlare di «odio per i musulmani» o di «ricostruzione della grande Russia» è esagerato, come definire Navaln’yj neofascista o neonazista. Sono espressioni usate di solito da chi vuole screditare la figura di Naval’nyj e di qualunque oppositore a Putin. Le posizioni di Naval’nyj come politico non erano così definite ed estreme e vanno valutate tenendo conto del contesto russo. Di Naval’nyj, in questi giorni parlano anche persone che non sempre hanno conoscenza specifica della sua personalità e della situazione concreta in Russia. Cordiali saluti. LL