
Come si è giunti agli attentati del 13 novembre a Parigi? Come dovremmo comportarci con i regimi dittatoriali del Medio oriente? Cosa possiamo fare come singoli individui? Queste domande, negli ultimi giorni, sono state ripetute più volte, ma nelle relazioni internazionali non si può quasi mai indicare «la» causa di un evento. Spesso non ci sono nessi causali diretti e spiegazioni logiche.
Il terrorismo internazionale sorge da una rete globale di elementi interconnessi. Spesso non ci sono nessi causali diretti e spiegazioni logiche. Si dice e si sente che le relazioni internazionali dipendono da decisioni politiche. Questa definizione è incompleta: la politica ha un ruolo, ma è solo uno dei molti attori delle relazioni internazionali. Le lingue e le culture, le religioni e le etnie, l’economia e la circolazione dei capitali, i singoli cittadini, le ONG e le imprese, le organizzazioni e istituzioni internazionali, la collaborazione transfrontaliera tra polizie e amministrazioni, i dati di fatto sociali, storici e geografici, persino la criminalità organizzata internazionale sono alcuni dei soggetti interagenti sul teatro del mondo. Il terrorismo di oggi è la tempesta perfetta delle relazioni internazionali: unisce nel terrore moventi culturali e politici, il comportamento di singoli individui con il contesto sociale e con situazioni oggettive come geografia, storia, religione. Non si potrà scoprirne una causa. Ci troviamo dinanzi a un complesso di interazioni e interdipendenze. Se una farfalla batte le ali a Pechino, a New York può scatenarsi una tempesta: questa celebre citazione viene spesso ripresa come motto delle relazioni internazionali. Descrive con rara efficacia anche la situazione rispetto al terrorismo globale. Dobbiamo abituarci a reazioni a catena complesse, anche non lineari.
Mi pongo ora davanti a questo intreccio enigmatico e tento di estrarne alcuni elementi che lo agitano, collegati a tanti altri.
Il retroterra politico. Dopo gli attentati del 13 novembre mi sono tornati in mente i discorsi di Barack Obama e Vladimir V. Putin dinanzi all’Assemblea generale delle Nazioni unite del 28 settembre scorso. Li avevo sentiti da capo a fondo e in lingua originale. Entrambi gli interventi mi avevano lasciato un’impressione di ipocrisia e debolezza. Obama e Putin guidano gli unici Paesi che nel contesto attuale potrebbero fare mosse decisive. Entrambi i Capi di Stato hanno parlato di «valori,» ma non hanno dimostrato di intendere, con questa espressione, le stesse cose. Obama, con il suo idealismo debole, guidato da una logica di rational choice, vuole vincere il cosiddetto «Stato islamico» abbattendo il regime dittatoriale siriano. In ciò, gli Stati uniti cooperano con altre, non meno rigide dittature della regione, senza, a quanto pare, porsi particolari problemi. Putin vuole raggiungere lo stesso fine, ma, a suo dire, la vittoria sull’«ISIS» è possibile solo con la collaborazione del Governo siriano in carica. Contro l’«ISIS» bisognerebbe formare una coalizione mondiale: il Presidente russo si richiama esplicitamente all’alleanza tra gli Stati uniti e l’Unione sovietica contro le dittature europee del XX secolo, alla fine della Seconda guerra mondiale. Putin parla come un idealista ma agisce ormai da tempo sulla scena mondiale come un realistaaggressivo: un quadro simile a quello di Georg W. Bush dopo l’11 settembre 2001. Sembra chiaro che i Presidenti di Russia e Stati uniti non pensano prioritariamente alla distruzione dei focolai del terrorismo in Medio oriente. Il loro obiettivo è il mantenimento di vantaggi relativi nel controllo della regione. La relazione fra lo «Stato islamico» e le celle terroriste che attuano gli attentati in Europa, del resto, poggia proprio su una di quelle equazioni non lineari citate sopra: la relazione esiste, ma come funzioni esattamente, nessuno sembra ancora saperlo in dettaglio.
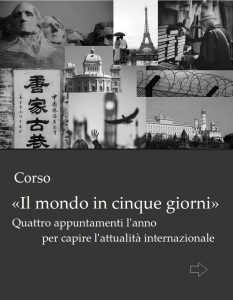
Ora, sul teatro di guerra. Oggi Putin offre all’occidente la collaborazione con la Russia nella lotta contro l’«ISIS» in Siria. Sembra, lì per lì, suonar bene: Putin «è l’unico che finalmente fa qualcosa contro il terrorismo,» perché non collaborare? Ma quale posizione ha preso la Russia verso l’occidente? Dal 2007 Putin costruisce la sua strategia in modo sempre più chiaro sulla svalutazione dell’occidente, in quanto civiltà in decadenza. Con la crisi ucraina, questa impostazione spregiativa ha raggiunto il suo apice. Le argomentazioni, nelle ultime settimane e mesi, si sono un po’ annacquate, ma l’orientamento di fondo resta invariato: l’occidente è una società debole, corrotta, ricaduta nell’incultura «fascista.» I media ufficiali russi diffondono ormai da anni questa narrazione, allo scopo di definire la posizione della Russia rispetto all’occidente. L’opinione pubblica occidentale non recepisce questa rappresentazione, i Paesi occidentali fanno poco o nulla per contrastarla. Alcuni media europei e circoli politici degli orientamenti più diversi sostengono addirittura le tesi di Putin. Nel frattempo, Mosca ha annesso di fatto la Crimea ucraina, in Georgia, Moldavia e Ucraina orientale la Russia ha violato importanti principi del diritto internazionale. Alimenta in quelle regioni degli Stati fantoccio al di fuori di ogni regola internazionale riconosciuta, costruiti causando migliaia di vittime e ingenti danni materiali. Ora Putin aspira a un’alleanza con l’occidente contro il terrorismo internazionale, sulla base di comuni valori di civiltà. Ancora una volta: quali valori e quale civiltà dovremmo indicare come base comune? La (n)ostalgia dell’Unione sovietica e della grandeur zarista che oggi permea la Russia? Una nuova edizione della dottrina delle zone d’influenza di Monroe? La coalizione con l’Unione sovietica di Stalin contro fascismo e nazionalsocialismo costò quasi cinquant’anni di dittatura nell’Europa dell’Est. Quanto costerà ora la «cooperazione» con la Russia nella lotta al terrorismo? Noi occidentali, che nella visione di Mosca veniamo ormai solo tenuti al guinzaglio da neofascisti, siamo improvvisamente tornati a essere bravi amici? Cosa succederà dopo un eventuale intervento militare comune in Siria? Chi mette a disposizione le necessarie truppe di terra? Le risposte non ci sono.
La religione ha un ruolo, negli attentati di Parigi? L’esistenza di un terrorismo di matrice islamica non trasforma ogni mussulmano in un terrorista; l’esistenza di preti pedofili non trasforma ogni cristiano in un violentatore. Queste constatazioni fin troppo evidenti non centrano il problema e non fanno progredire, euristicamente, di un sol passo. Accadono atti terroristici in nome di una religione. Ciò significa che esistono individui che collegano una religione all’assassinio politicamente motivato. In Europa vi sono quantità non trascurabili di cristiani cattolici e ortodossi che sostengono tesi nazionaliste e xenofobe. Vi sono media cattolici conservatori, con forte e acritico seguito presso strati non insignificanti di popolazione, che alzano la loro voce contro i principi dello Stato di diritto, disprezzano come inganno dell’anticristo lo sviluppo intellettuale europeo dal quale sono sorte le nostre libertà fondamentali e non tralasciano di richiamare argomenti antisemiti. Vi sono regioni d’Europa, penso ad esempio all’Italia meridionale, nelle quali la Chiesa sembra preferire la vicinanza della criminalità organizzata, a una relazione trasparente con lo Stato di diritto. Dall’inizio degli anni Settanta abbiamo pensato che la religione fosse ormai cosa per uomini deboli e creduloni. Per decenni abbiamo tollerato la radicalizzazione dei predicatori nelle periferie delle città europee, considerandola un fenomeno marginale. Oggi quelle periferie di Parigi e Bruxelles sono diventate delle aree quasi extraterritoriali, nelle quali crescono società parallele, si commerciano tranquillamente armi e si organizzano attentati. Il vecchio argomento secondo cui gli individui, in quei luoghi, diventano terroristi a causa della povertà e dell’esclusione sociale, non basta più. Che non ogni cristiano è un antisemita, che non ogni mussulmano è un terrorista, lo capisce anche un bambino. Invece di giocare con la logica infantile, dovremmo riconoscere che con determinati circoli religiosi, di diverse confessioni, abbiamo un problema. Non solo un problema soggettivo con singoli fedeli, ma un problema oggettivo nel rapporto fra religione e Stato di diritto. La separazione fra Chiesa e Stato è una conquista fondamentale della storia europea. Presso alcuni fedeli, la lealtà verso la religione sembra ancora essere più importante del rispetto dei principi del patto sociale che è fondamento di una società aperta. Le microsocietà autocratiche sviluppatesi nelle periferie europee, che oggi offrono confortevole ospitalità ai terroristi, possono svilupparsi fra quaranta, cinquant’anni in altre aree, con altri scopi e altre religioni, se non si riconoscono e non si contrastano tempestivamente i primi segni del loro formarsi.
Come dovremmo comportarci noi, come società occidentali, con i regimi dittatoriali del Medio oriente? Possiamo tollerare l’esistenza di quei Governi, giustificandoci con il realismo. Possiamo far cadere i dittatori e avviare idealistici processi di nation building dai quali sorgano delle società libere. La prima alternativa suona male, ma garantisce stabilità. La seconda suona bene ma spesso non funziona, poiché di solito, accantonato l’idealismo di facciata, viene utilizzata come pretesto per costruire delle zone d’influenza. Un modello per gestire con successo questa relazione oggi, su un pianeta globalizzato, non ce l’abbiamo ancora. E noi, come singoli individui, cosa possiamo fare?La risposta, qui, è notevolmente più breve: diffidare delle soluzioni semplici.
| >Originale in lingua tedesca (traduzione italiana dell’autore).


Fausto says:
Salve Luca,
Concordo con l’analisi ma, secondo me, una soluzione «semplice» ci sarebbe: smetterla una volta per tutte di parlare di «valori» solo quando si è vittime e, di conseguenza, smettere di ergersi ipocritamente a difensori della democrazia quando e dove conviene, e in ogni caso mai con le bombe. Forse sarò troppo semplicistico come al solito, ma ritengo che la religione faccia più che altro da «collante,» e poi da motivazione, per individui che o sono emarginati o non trovano alcun valore nelle società che li ospitano, anzi, vedono che i governi di queste società continuano a esportare la guerra nei Paesi musulmani. Togliere una motivazione di risentimento agli individui più deboli o influenzabili, sarebbe già un grosso passo in avanti.
Infine una considerazione sulla Francia. Non è da adesso (e neanche da gennaio) che nella società francese c’è un problema con gli immigrati, particolarmente del Magreb. Anni fa ci fu una rivolta con l’incendio di numerose auto e un mio collega francese mi disse che era accaduto già diverse volte. Per sfuggire all’asfissiante retorica che scatta in questi casi, ho guardato anche canali diversi da quelli occidentali Ad es. Russia Today (lungi da me l’asserire che Putin abbia la verità e la ragione in tasca, ma questi dati mi sono sembrati interessati) ha elencato una lunga serie di accoltellamenti perpetrati da musulmani nei confronti soprattutto di soldati francesi; parallelamente è aumentata la violenza opposta, verso i musulmani. Secondo me in un terreno così fertile, certe idee attecchiscono meglio che altrove.
Luca Lovisolo says:
Buonasera Fausto,
Grazie per il Suo commento. Devo confessarle di usare io stesso con disagio l’espressione «valori,» poiché spesso è sinonimo di ottuso conservatorismo, oppure, come Lei osserva, di visioni parziali. In realtà vi sono «valori» che la civiltà europea ha sviluppato specificamente, in primo luogo la centralità della persona umana, che non è un’esclusiva del cristianesimo, ma un dato costitutivo della ricerca intellettuale europea dalla fine del Medioevo in poi. Sarebbe già molto se queste tragedie ci rendessero attenti a questa nostra peculiarità, che altre culture non hanno, come ben si vede. Se vi fossimo più attenti, potremmo fare molto già con l’esempio, senza bisogno di arrivare al punto in cui, per difenderci, l’uso della forza diventa inevitabile.
Certo, togliere masse di individui dall’emarginazione delle periferie eliminerebbe già uno stimolo a delinquere, ma gli ultimi sviluppi dicono che non è questa la sola causa e forse nemmeno la principale. Oggi nel terrorismo si arruolano giovani senza particolari difficoltà economiche o di integrazione. Il problema, perciò, si è esteso. Come ho ricordato nell’articolo, credo che troppi anni di illusione positivista ci abbiano fatto dimenticare quanto a fondo può scavare la predicazione religiosa estremista, di qualunque fede. Non dimentichiamo che negli Stati uniti vi sono cristiani che predicano (e talvolta attuano) la violenza contro i medici abortisti. Le chiese sono vuote, ma le coscienze in cerca d’autore continuano a trovarlo in predicatori senza scrupoli alla radio, in TV e chissà dove ancora.
Quanto alla Francia, concordo con Lei che con l’immigrazione ha un rapporto fatto di molte sfaccettature, che rimonta alle vicende della decolonizzazione, prevalentemente d’Algeria, senza poter approfondire qui il discorso.
Cordiali saluti
LL