
Perché, occupandomi di diritto e relazioni internazionali, mi interessa la vicenda del politico italiano Nicola «Nichi» Vendola, a capo del partito politico più vicino all’eredità storica del comunismo italiano, che con la pratica del cosiddetto «utero in affitto» ha avuto recentemente un figlio nel quadro della sua relazione omosessuale?
Mi interesso dei Paesi dell’Est Europa, e non da ieri, ma da quando erano ancora «Paesi comunisti.» Non ho motivi per parlar bene di quei regimi, ma il distacco del ricercatore mi permette di riconoscerne alcuni meriti. Quando in Italia il divorzio era di fatto impraticabile e in Germania ovest una donna che volesse lavorare doveva chiedere il permesso scritto al marito (succedeva ancora negli anni ’70), nei Paesi dell’Est la donna godeva già di un’autodeterminazione simile a quella che conosciamo oggi, in alcuni casi superiore, se pensiamo, ad esempio, alla capillare rete di scuole dell’infanzia della Germania est e ai servizi sociali gratuiti presenti in quei Paesi.
Con l’eccezione della Romania di Ceaușescu, dove la donna era protagonista involontaria di una politica di filiazione simile a quella che fu praticata in Italia da Mussolini, propagandata dal Conducator di Bucarest con toni anticontraccettivi e antiabortisti che piacerebbero ancora a molti cattolici di oggi, la visione della donna nelle società socialiste era notevolmente più avanzata rispetto a quella che negli stessi anni se ne aveva in Occidente. Certo: la donna di famiglia era anche quella che si alzava alle quattro del mattino e andava a fare la coda a venti sottozero davanti al Produkty, sperando di riuscire ad aggiudicarsi una pagnotta prima che gli scaffali si svuotassero di nuovo, ma qui parliamo d’altro.
Cos’è l’«utero in affitto?» E’ una «locatio operis,» così chiamava il diritto romano ciò che noi oggi definiamo «lavoro autonomo.» Un committente «prende in locazione» per un certo tempo l’attività, fisica o intellettuale, di un prestatore d’opera, la «affitta.» Sembra strano, a noi, che abbiamo sviluppato una cultura del lavoro più rispettosa dell’individuo, ma l’origine dei contratti di lavoro è nei contratti di locazione, che nel linguaggio comune chiamiamo «affitto.» Quando incarichiamo un traduttore di tradurre un testo, «affittiamo» la sua competenza. Quando chiediamo a un falegname di ricavare da un pezzo di legno un pupazzo da esporre in giardino, «affittiamo» la sua abilità.
Una donna che genera un figlio, però, è un’altra cosa, per oggettive ragioni biologiche, non per nebbiosi credo religiosi o considerazioni morali. Diciamo allora «maternità surrogata?» Il termine «maternità» sposta la questione verso i diritti indisponibili, connessi ai rapporti naturali e familiari, che non si possono cedere, perciò neppure surrogare: i dubbi aumentano e molti ordinamenti la vietano. E se la donna è felice di farsi «affittare?» Vi sono diritti naturali e fondamentali la cui lesione non si può giustificare nemmeno con il consenso dell’avente diritto: non posso uccidere, ferire, sfruttare alcuno, nemmeno se me lo chiede. Il diritto protegge l’Uomo anche da se stesso, in questi casi, pensando che talvolta potrebbe non essere in grado di misurare le conseguenze dei propri atti. Vi sono, certo, donne che abbandonano i loro figli. Questa, però, è la perversione della maternità, non può essere assunta come una sua semplice variante, per giustificarne altre.
«Ma vuoi negare a una coppia omosessuale di avere gli stessi diritti di qualunque altra coppia?» Certamente no. Vuoi negare a un ragazzo nato senza mani il diritto di diventare pianista? No, non gli nego il diritto, ma senza mani il pianoforte non si suona, perciò, pur avendolo, quel diritto non potrà esercitarlo. Quel ragazzo, se ben indirizzato, potrebbe però diventare un ottimo musicologo, cioè uno studioso di storia, teoria, linguaggio della musica, rendere ugualmente un gran servizio e accettare più facilmente di non poter suonare.
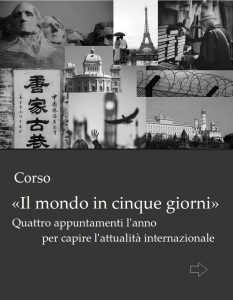
Il diritto naturale regola i rapporti più elementari, tra cui quelli personali e familiari. Il diritto positivo (cioè «posto» dall’Uomo per elaborazione intellettuale e scritto nelle leggi) prende ispirazione da quello: le norme del diritto di famiglia, ad esempio, si ispirano ai rapporti naturali, per integrarli con leggi che la natura non fornisce, ma che sono indispensabili, nella convivenza concreta. Ciò facendo, il diritto positivo non elimina quello naturale: oltre a questa funzione ispirativa, il diritto naturale mantiene una funzione di limitazione del diritto positivo, che, senza questo limite, potrebbe eccedere oltre ogni barriera. Chi ospitasse la propria madre anziana in una propria casa e volesse far soldi, potrebbe scacciarla e vendere l’abitazione: nessuna norma di diritto positivo potrebbe impedirglielo. Tutti avvertiremmo però l’innaturalità di quella decisione, cercheremmo di indurre l’interessato a non agire in quel modo e lo isoleremmo socialmente, se così agisse. Anche il giudice, se adito, cercherebbe nel diritto naturale del rapporto madre-figlio il limite da imporre alla libertà dispositiva di quest’ultimo.
Chi, come gli omosessuali o le coppie eterosessuali sterili, pur per ragioni diverse, non può avere figli naturalmente, non è privato del diritto di averne: deve accettare però che esiste una causa naturale che ne limita l’esercizio. Le fonti di questa limitazione sono da ricercare non in qualche religione o in considerazioni morali(stiche), ma nel diritto naturale, che può aiutare a trovare risposte quando dobbiamo decidere cosa è giusto e cosa non lo è. Poiché – udite, udite – stabilire cos’è giusto e cosa non lo è, si può: l’oggettività è viva e lotta insieme a noi, potremmo dire, parafrasando un motto che non dispiacerebbe a Vendola. Non è «tutto relativo» e non vi è sempre la scappatoia nel beneficio del dubbio, poiché il dubbio, metodologicamente, è un punto di partenza, non un punto di arrivo. Chiudere la questione con un «dipende dalle circostanze» non è un’opzione, vuol dire non cominciare neppure a occuparsene. Un giudizio va dato e motivato, con una chiara assunzione di responsabilità, e gli elementi per farlo ci sono, se si vuole, senza bisogno della morale o della religione.
Quando si usa la parola «diritto» bisognerebbe sempre ricordare che non significa «libertà di…» ma «limitazione alla libertà di…» nell’interesse di una possibile convivenza tra umani. La mediazione va trovata nel punto d’equilibrio tra le libertà dei singoli. I rapporti naturali restano a fare da guida, in questo non facile esercizio. Se non si vuole tener conto di tutto ciò, allora la parola «diritto» è fuori luogo: si deve, piuttosto, parlare di arbitrio dell’indifferenza. E’ una delle posizioni che si sono sentite e lette, in questi giorni: in fondo, che me ne frega? Se non danneggia me, saranno affari suoi, di Vendola, della donna e del bambino, perché dovremmo prendere una posizione? Contenti loro… E i neogenitori, perché dovrebbero preoccuparsi d’altro, se non della realizzazione del loro desiderio?
In una società nella quale «diritto» diventa sinonimo di pretesa assoluta, indifferente a ogni limitazione imposta dal patto sociale e persino dai rapporti naturali più elementari, prima o poi a imporsi è la legge del più forte: lo stesso Vendola ha potuto avere un figlio perché è forte. La sua posizione privilegiata gli permette addirittura di contraddire se stesso: se anche perdesse il suo ruolo o fosse allontanato dal partito, può fregarsene, ha risorse a sufficienza anche senza lavorare. Ha dimostrato lui stesso che la «cultura dei diritti» da lui continuamente propugnata apre la strada al privilegio del più forte, se per «diritto» si intende l’arbitrio dell’indifferenza. Nel suo Paese, la pratica dell’«utero in affitto» è reato. Ciò significa che questa pratica, per l’ordinamento italiano, lede un interesse pubblico, individuato nella dignità della donna e nell’interesse del minore: non si tratta solo di un interesse privato, che si può regolare con un qualunque rapporto contrattuale civilistico, come un contratto d’affitto, e che la collettività può anche ignorare all’insegna del «sono fatti loro.» La legge italiana può non piacere, ma è quella che vale.
Vendola, perciò, si è recato all’estero. Il reato della maternità surrogata, in Italia, è perseguito secondo il principio di territorialità, cioè se compiuto nel territorio dello Stato, e non secondo il principio di personalità attiva, ossia applicando la legge dello Stato di cui l’agente è cittadino, ovunque abbia commesso il fatto (come invece taluni reati connessi al cosiddetto «turismo sessuale» o alla riduzione in schiavitù, ad esempio, puniti dalla legge italiana ovunque commessi nel mondo). Per questi motivi, Vendola non è perseguibile: ciò lo sottrae alla competenza del giudice, ma non al giudizio sociale, aggravato dalla circostanza di essere una persona pubblica. Materialmente ha compiuto un fatto che nel Paese del quale è cittadino e parlamentare (perciò legislatore) è sanzionato penalmente in quanto lede un interesse pubblico. Ha la forza per permettersi anche questa condotta, può fregarsene.
Perché non ha fatto pesare il suo ruolo istituzionale, ad esempio, per promuovere una legge più agile su forme di adozione o affidamento che permettano, a chi come lui vuole impegnarsi nella crescita di un minore senza poterne generare naturalmente, di togliere un bambino o un adolescente senza famiglia dai corridoi algidi di qualche istituto per orfani? Può permettersi di fregarsene.
Nel conformista dibattito italiano, chi solleva obiezioni sulla condotta del politico pugliese viene normalmente zittito dalle voci dominanti. Sul fronte opposto vi sono movimenti cattolici oltranzisti che si ammantano di una missione divina, come leggevo stamattina a proposito della fondazione di un partito nato a seguito della triste e controversa manifestazione «Family day.» Costituendo questo partito, i fondatori vantano di attuare «un disegno di Dio» e allignano altre affermazioni che è imbarazzante persino citare tra virgolette. In queste contrapposizioni di estremi, l’immaturità della società italiana si mostra ancora una volta in tutta la sua irrisarcibilità.
Tornando, per chiudere, ai miei amati Paesi dell’Est Europa: finiti i regimi comunisti, dopo venticinque anni di difficile ripresa vi stanno avvenendo rivolgimenti che preoccupano l’intero Continente. Crescono i movimenti ispirati al nazionalismo estremista e a un cieco conservatorismo cattolico, mentre i partiti «di sinistra» attraversano serie difficoltà. In Polonia, dopo le ultime elezioni, nessuno di questi è presente in Parlamento: questo dato deve preoccupare anche chi non li vota. La noncuranza di Nichi Vendola, oltre alle considerazioni fatte sopra, cade come un macigno sulla credibilità di un pensiero politico che certo, ha prodotto dittature sanguinarie, ma, laddove ha saputo evolversi rispettando i fondamenti dello Stato di diritto, ha dato un contributo essenziale allo sviluppo della società europea durante tutto il Novecento, proprio sul piano della socialità, dell’equità e del ruolo della donna.
Ma lui, in fondo, ormai può fregarsene. «Me ne frego, non so se ben mi spiego / Me ne frego, fo quel che piace a me.» Così recitava il ritornello di una canzone italiana di successo degli anni Trenta. Era uno degli inni del fascismo.


Elena says:
La tua ricchissima riflessione mette in gioco temi «da far tremar le vene e i polsi,» e che vanno molto al di là delle considerazioni, pur corrette e necessarie, sulla vicenda Vendola. Il tema che personalmente mi suscita più di una domanda è quello del limite.
Sappiamo che la storia dell’uomo è attraversata dal desiderio di superare i limiti imposti dalla natura: dalla costruzione del primo utensile, la tecnica ha rappresentato una continua sfida ai limiti fisici del nostro corpo. La medicina stessa, per definizione «techne,» da pratica sciamanica strettamente legata al soprannaturale e ad una natura divinizzata, ha progressivamente accettato la sfida di superare i limiti imposti dalla natura, dalla nascita alla morte dell’individuo. In questo contesto, l’asticella del limite fisico si abbassa ogni giorno di più, in nome di quel principio di autodeterminazione e di una legittima ricerca della felicità e del benessere individuale che è un vanto delle società occidentali.
Non è escluso pertanto che, con il progresso delle tecnologie protesiche, l’aspirante pianista senza mani possa arrivare a realizzare le sue aspirazioni, esattamente come già ora, con una buona dose di determinazione, tante persone affette da gravi limiti fisici possono fare cose una volta impensabili. Anche il ricorrere alla tecnica per superare altri limiti fisici come la sterilità di coppia è considerato alla stregua di una terapia (sterilità:fecondazione assistita = malattia:cura), di mezzo per abbattere un limite che si vive come ostacolo alla propria realizzazione personale. Lo stesso per la maternità surrogata (in uso da decenni tra le coppie eterosessuali), una pratica che ci si illude di poter assolvere eticamente ricorrendo ad una rigida formalizzazione contrattuale. In molti paesi occidentali il principio giuridico in base al quale non è consentito recar danno a un individuo nemmeno se questi è consenziente è già stato ampiamente scavalcato in nome del principio di autodeterminazione, ad esempio con la legalizzazione dell’eutanasia (senza contare quanto è già stato più o meno sdoganato nel comune sentire, vedi le pratiche sadomasochiste, per dirne una).
A me sembra che in questo momento ci si trovi davvero ad uno snodo, una resa dei conti a cui inevitabilmente ci ha portato il conflitto mai risolto tra individuo e società, natura e cultura. Quanto vale l’individuo e la sua legittima aspirazione alla felicità davanti al limite imposto dalla natura o banalmente dalle circostanze e dagli usi sociali? Che fine fa il diritto naturale in una società che non è in grado di concepire il limite? Sono tutte domande aperte, alle quali è difficile dare una risposta prescindendo da riflessioni articolate e complesse sulla natura umana stessa. Per questo motivo forse la risposta più semplice per sgravarsi le coscienze è quella che tu citi: siccome non mi danneggia in modo diretto, dichiaro che la tal condotta è un diritto. E’ una posizione frutto del pensiero sociale debole tipico delle società occidentali.
Luca Lovisolo says:
Grazie per il commento. Non ho considerazioni da fare sulla fecondazione eterologa in sé: osservo che l’ordinamento italiano ne dà un certo profilo, a prescindere da ciò che potrei pensarne io personalmente, e rilevo una serie fatti. Se la sensibilità cambia, perché la tecnica rende possibili o accettabili talune pratiche, bisogna cambiare la legge. Se la legge continua a esistere e non si forma un consenso per modificarla, è possibile che quella sensibilità non sia ancora maturata presso un numero sufficiente di persone. D’altra parte, proprio in Italia il dibattito sulla costituzionalità della legge è aperto e spesso deciso a suo sfavore. Quanto all’eutanasia, citata come esempio: vivo in un Paese dove l’eutanasia è legale, ma assicuro che questa pratica è tutt’altro che indiscussa, nel dibattito sociale, anche perché avviene interpretando una norma del Codice penale svizzero molto sul filo del rasoio, con non infrequenti casi dubbi, soprattutto per quanto riguarda il requisito della gratuità.
Proprio nei momenti in cui si registrano grandi mutamenti, il limite del diritto naturale torna utile. Non significa che non lo si possa superare: per superare o spostare un limite, però, è necessario che questo esista e sia conoscibile. Non credo che lo si possa definire attraverso gli estremismi delle correnti religiose, politiche o morali. Così il divieto di fecondazione eterologa della legge italiana diventa una fatto «cattolico» rifiutato dagli altri solo in quanto tale: non mi risulta, poi, per quanto lo conosco, che il mondo cattolico sia poi così unitario, sul punto, ma quello che passa è il messaggio più estremista, dall’una parte e dall’altra. Questo non è accettabile neppure per chi, come me, non è interessato alle posizioni «cattoliche,» ma non per questo rifiuta la sfida intellettuale di analizzarne le motivazioni.
A volte basterebbe pensare al significato delle parole, questo aiuterebbe già molto a capire con cosa si sta avendo a che fare. Invece, si usano termini come «utero in affitto» o «maternità surrogata» che richiamano istituti estranei alla materia o sono evidentemente contraddittori, entrati nel linguaggio comune con la prepotenza dei media a portare confusione.
Credo, infine, che si dimentichi troppo spesso una cosa: è vero che tendiamo sempre a superare i nostri limiti, e questo è un bene, perché ci fa progredire. Non si dovrebbe trascurare, però, che anche riconoscere qualche nostro limite può farci crescere: si matura anche accettando la propria bassa statura pur volendo essere più alti, la propria mancanza di talento anche se si vorrebbe diventare artisti e si deve rinunciare, la propria impossibilità di avere figli pur volendone dal profondo del cuore. Il riconoscimento del limite può essere doloroso, ma può aprire spazi di realizzazione diversi ed essere un forte momento di maturazione e presa di coscienza di sé, mentre l’insistere sul superamento di un limite non fa che aumentare la frustrazione, o, peggio, indurci a scaricarla su altri, come figli voluti a tutti i costi e generati chissà come.
Mi sembra che l’accettare un limite sia sempre e solo visto come un atto di rinuncia, di repressione, di privazione di un «diritto.» Possiamo essere limitati in qualcosa, anche in modo iniquo rispetto agli altri: «Perché gli altri sì e io no?» Perché gli altri sì e tu no, punto, a volte succede. Abbiamo il dovere soggettivo di provare a superare i nostri limiti, lo Stato ha il dovere oggettivo di fornire strumenti che appianino le iniquità sociali, ma se ciò espone noi o gli altri a discostarci persino dal buon senso e dobbiamo accettare una limitazione, ciò non è per forza una rinuncia a evolvere, forse proprio il contrario. In questo, i limiti segnati dalle situazioni oggettive naturali, anche se non devono diventare dogmatici, sono punti di riferimento che non andrebbero archiviati troppo in fretta.
Elena says:
Sul limite la penso esattamente come te. Ma in che modo una norma etica soggettiva può essere usata nel diritto positivo? Si tratta di temi affascinanti e complessi che non hanno una soluzione semplice. I nodi irrisolti che ho citato prima (natura/tecnica; individuo/società…) rimangono e purtroppo non vengono quasi mai affrontati, come invece hai fatto tu, con quell’obiettività che eviterebbe di renderli vessilli di ideologie religiose o al contrario brutalmente tecniciste. Ho cercato di non dare giudizi personali su pratiche mediche estreme così delicate e controverse, proprio perché vorrei restare nel solco, per quanto possibile, della razionalità. Ma la vicenda di Vendola & co. mi fa venire in mente Bauman e la sua società liquida, nella quale il cittadino diventa un consumatore (in questo caso un ricco consumatore, quindi in posizione di particolare forza) che aspira al solo soddisfacimento del bisogno personale hic et nunc, con un’identità sociale molto labile e mutevole a seconda delle convenienze. In questo contesto ogni desiderio rischia di essere rivendicato come diritto. Anche su questo mi trovo assolutamente d’accordo con te. A questo punto ci sarebbe da aprire una discussione sul concetto di felicità, ma mi fermo qui perché ho già ampiamente abusato del mezzo e della tua pazienza.
Luca Lovisolo says:
In realtà credo che la capacità di accettare un limite, in quanto scelta etica soggettiva, appunto, non debba neppure entrare strettamente nel diritto. Dovrebbe essere compito degli educatori, abituare sin da giovani al fatto che accettare un limite non è per forza una sconfitta, ma può essere un valore. Ne nascerebbe una società più capace di autoregolarsi e che, in conseguenza, sarebbe meno disponibile anche ad approvare leggi contrarie a questo spirito. Purtroppo questo tipo di educazione è andato perso, tanto che i genitori non educano più i figli neppure all’accettazione di un brutto voto a scuola, ma si scagliano contro l’insegnate che l’ha dato.
Quanto alla deriva del dibattito pubblico, il problema nasce dalla necessità di estremizzare il conflitto per ragioni politiche e di comunicazione. Riportare la questione a una visione ragionata, almeno su alcuni punti, come ho provato a fare, non è poi così difficile, come si vede: basterebbe volerlo, ma non conviene a nessuno, perché in politica e nei media oggi pagano gli estremismi, anche assurdi. Il pubblico si accoda volentieri all’uno o all’altro, fa comodo a tutti. I pochi che fanno domande restano minoranze non rilevanti.
Quanto a Nichi Vendola, un politico che prima di questo gesto stimavo di più, a stimolarmi a scrivere è stato proprio il contrasto fra la sua condotta e i valori di cui lui e il suo partito si fanno portatori, unito alle mie conoscenze dei Paesi ex comunisti. Vien da chiedersi se la «cultura dei diritti» che spesso gli si sente propugnare vada letta come «cultura della responsabilità,» come dovrebbe essere, oppure come «cultura del fare quel che mi va.» In questo secondo caso, la società viene di fatto consegnata alla legge del più forte, in barba a ogni ideale di equità. Lui stesso si è trasformato in prova vivente di questa regressione. Da lì sono partite le mie considerazioni, non certo dalla volontà di analizzare la questione della fecondazione eterologa per sé, verso la quale, oltre tutto, non provo nessun particolare interesse.