
La lunga vicenda dei due militari italiani trattenuti in India per esservi sottoposti a processo, con l’imputazione di duplice omicidio, ha fatto registrare in questi giorni una svolta, con il rilascio di uno dei due protagonisti, che è rientrato nel proprio Paese. Com’è purtroppo frequente in Italia, del caso sono sorte visioni del tutto parziali: chiariamo alcuni elementi oggettivi dell’accaduto.
Le diverse e opposte letture del caso mirano, da una parte, a rinfocolare sentimenti nazionalistici e, dall’altra, a proporre tesi astrattamente ostili a qualunque azione svolta da militari o forze dell’ordine. In particolare, su una nota rete di socializzazione è nata una discussione sul fatto che i due militari italiani fossero qualificabili come contractor, cioè svolgessero il loro compito di protezione come parti di un contratto privato con l’armatore della nave sulla quale si trovavano. A una lettura superficiale, il ruolo dei nuclei militari posti a protezione di navi civili in navigazione si presta effettivamente a essere confuso con quello dei cosiddetti contractor, confusione che dà la stura a strampalate letture politicizzate della vicenda, nota nel frattempo come «caso marò.» Scopo di questo articolo è chiarire se la definizione di contractor abbia una giustificazione oggettiva in questo caso e concludere con alcune considerazioni generali sul merito della controversia.
La presenza di militari a bordo di imbarcazioni civili a difesa di esse in acque pericolose non configura un rapporto privatistico tra l’armatore e i militari stessi. Essi sono agli ordini del comandante civile della nave perché quest’ultimo vi esercita la massima autorità. Si tratta senz’altro di una situazione anomala, giustificata dalla particolarità dell’esigenza, ma ciò non muta lo status dei militari coinvolti, che sono e restano tali, non parti di un rapporto di diritto privato.
Il provvedimento italiano che regola l’istituto dei Nuclei militari di protezione di navi civili (NMP), il Decreto legge 12 luglio 2011, n. 107, art. 5, in particolare ai nr. 1 e 3, non difetta di determinatezza, su questo punto: vi si parla di «convenzioni» tra il Ministero della difesa italiano e armatori privati, non di «contratti.» In tali rapporti giuridici l’obbligazione dell’armatore non è il pagamento di compensi o corrispettivi, ma il «ristoro dei corrispondenti oneri […] mediante versamenti all’entrata del bilancio dello Stato» poi totalmente riassegnati all’amministrazione competente. Per questi motivi, è chiaro già dal linguaggio della norma che l’attività di questi nuclei militari non avviene in forza di un rapporto privatistico, ma è un’attività dello Stato destinata a soddisfare un bisogno pubblico divisibile (la sicurezza delle navi, in questo caso) svolta su richiesta (degli armatori) e finanziata con un versamento ben più assimilabile a un tributo pubblico divisibile, che a un’obbligazione sorta da un rapporto privatistico.
Il contractor è, invece, un soggetto privato (singolo operatore o impresa di sicurezza) che presta un servizio sulla base di un normale contratto, le cui obbligazioni sono, da parte del contractor stesso, prestare un servizio di protezione, e, da parte dell’armatore, compensarlo con un corrispettivo in denaro. La differenza non è né puramente accademica né di poco conto, poiché influisce, tra l’altro, proprio sullo status del personale coinvolto e pertanto anche sulla sua situazione processuale, in caso di eventi come quello che ha coinvolto i due militari italiani. Si pongono, infatti, molti problemi, a partire dall’immunità funzionale, sino alla questione della catena di comando e della competenza territoriale, quest’ultima regolata in modo diverso, a seconda che si tratti di soggetti civili o di personale militare.
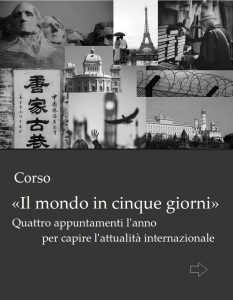
Non vi è dubbio che l’impiego di militari a protezione di navi civili abbia rappresentato un caso particolare che ha sollevato numerose contraddizioni giuridiche e operative. Anche per questo motivo, nel 2015, il legislatore italiano ha soppresso tale possibilità, riservando i servizi di protezione di imbarcazioni civili a soli operatori di sicurezza privati, per i quali è sì corretto utilizzare il termine contractor, volendo proprio avvalersi di un anglicismo.
Per le ragioni riassunte sopra, perciò, i due «marò» italiani a bordo della nave Erica Lexie non erano contractor. Qualunque considerazione che parta dall’assunto che lo fossero è, in conseguenza, destituita di fondamento, quale che sia il retroterra politico da cui nasce.
Il fatto imputato ai due militari italiani, l’uccisione di due pescatori di nazionalità indiana, si è svolto tra le 20 e le 30 miglia marine dalla linea di base, perciò in acque internazionali, abbondantemente oltre il limite delle acque territoriali indiane, fissato in 12 miglia. Il luogo del fatto si trova però all’interno della cosiddetta «zona contigua,» nella quale lo Stato costiero non ha diritti sovrani e di giurisdizione, può esercitare unicamente alcune attività di controllo o inseguimento specificamente previste dal diritto internazionale e comunque estranee alla fattispecie di cui si tratta. Con argomentazioni di diritto interno e insinuandosi in alcuni recessi di vuoto legislativo, l’India ritiene invece di avere propri diritti sovrani anche sulla zona contigua e pertanto di esercitarvi la giurisdizione, che le conferirebbe il diritto di giudicare il caso. Le argomentazioni indiane non sembrano convincenti, ma hanno rallentato il regolamento di competenza tra i due Paesi coinvolti.
Se le responsabilità dei fucilieri italiani devono ancora essere accertate, vi sono responsabilità che appaiono già chiare, anche se sinora, probabilmente per ragioni di opportunità, non sono state evidenziate e perseguite. Tali responsabilità sono in capo a coloro che in Italia hanno gestito il «caso marò» dimostrando una superficialità che dovrebbe preoccupare tutti, dall’autorizzazione data alla nave di entrare in acque indiane, ai maldestri tentativi di conciliazione stragiudiziale con le famiglie delle vittime, sino al ritardo inspiegabile con cui l’Italia ha adito il competente Tribunale internazionale del diritto del mare per affidargli un definitivo regolamento di competenza secondo il necessario criterio di terzietà. Se si fosse proceduto sin da subito come dovuto, con ogni probabilità il «caso marò» sarebbe già deciso o non si sarebbe neppure posto.
L’Italia ha invece ritenuto che il caso si potesse risolvere per via di negoziazione politica, anziché per via giudiziale. Ha commesso, in ciò, un errore di valutazione che dimostra, se ve ne era bisogno, lo straniamento della vicina Penisola rispetto ai rapporti di forza internazionali oggi esistenti. I numerosi Governi, di vario segno, che a Roma si sono succeduti nella gestione del «caso marò,» sembrano aver assunto che la parola di un singolo, piccolo Stato europeo, per giunta indebolito dal suo scarsissimo credito internazionale, sia ascoltata oggi, da Paesi ancora considerati in via di sviluppo, con lo stesso timore riverenziale con il quale era ascoltata sino ad alcuni decenni or sono.
Non è più, visibilmente, il caso. I nuovi Paesi emergenti sanno molto bene quale potere ricattatorio possono esercitare sui piccoli Stati europei, nel quadro dei nuovi equilibri geopolitici ed economici globali. Pur su piani diversi, insieme al caso del terrorista Cesare Battisti, del quale l’Italia non riesce a ottenere la consegna dal Brasile, e il recente, penoso caso del giovane ricercatore Giulio Regeni, torturato e ucciso in Egitto, anche il «caso marò» attesta, da una parte, quanto uno Stato che si fonda, pur con tutti i suoi difetti, sui principi europei dello Stato di diritto, sia esposto a ricatti da parte di Stati che tali principi abilmente aggirano; dall’altra, ricorda a tutti l’urgenza di rafforzare un’unità europea capace di opporre a tali condotte il peso di un intero Continente, non le velleità di singoli Stati europei ormai privi di sovranità sostanziale, se confrontati alla forza e spregiudicatezza dei soggetti che oggi determinano i rapporti globali.
Quanto alle responsabilità dei due militari italiani, esse andranno accertate in un procedimento che dovrà svolgersi nei modi indicati dal Tribunale internazionale competente. Sino alla decisione del giudice, pertanto, non vi è ragione di commentare oltre ed è augurabile che il caso non venga ulteriormente colto come pretesto per momenti di spettacolo o di strumentalizzazione, da qualsiasi parte venga.

