
Il decreto appare frutto di superficialità e intaccato da una notevole misura di cinismo. Tuttavia, a stabilire se un provvedimento è anticostituzionale, in Italia, è la Corte costituzionale. Fino a quel momento, qualunque cittadino deve applicare e far applicare la legge. Non bisogna dare alle parole delle interpretazioni analogiche fuori luogo, altrimenti non si capisce più nulla.
Alcune risposte rapide alla questione italiana di queste ore. L’abrogazione della «protezione umanitaria» pone un problema concreto: come classificare e gestire gli stranieri presenti sul territorio che ne beneficiavano e ora cadono di fatto in clandestinità. Alcuni sindaci hanno segnalato che disapplicheranno, cioè consapevolmente non applicheranno, il cosiddetto «Decreto sicurezza» con il quale tale abrogazione è stata disposta.
Il rapporto con la Costituzione
Se il Decreto sicurezza è contrario alla Costituzione, perché il Capo dello Stato lo ha firmato? – A stabilire se un provvedimento è anticostituzionale, in Italia, è la Corte costituzionale. Il Presidente della Repubblica svolge un esame generale di costituzionalità, prima di firmare le leggi, ma non è suo compito entrare nel dettaglio. Se intravede elementi di macroscopica anticostituzionalità, può rinviare una sola volta il provvedimento al Parlamento, ma in questo caso non ha rilevato tale necessità. Se vi è chi ritiene che il decreto contenga specifici elementi anticostituzionali, deve eccepirlo dinanzi alla Corte costituzionale.
I sindaci possono ricorrere alla Corte costituzionale? – No. Il ricorso alla Corte è incidentale, cioè può avvenire solo durante un procedimento giudiziario: se il giudice o le parti di un processo ritengono che una legge utilizzata nel procedimento stesso sia anticostituzionale, chiedono alla Corte di decidere sul da farsi. Il ricorso in via principale, cioè indipendente da un processo, può essere depositato invece dalle Regioni, quando ritengono che un atto dello Stato centrale scavalchi le loro competenze. E’ ciò che ha annunciato di fare, ad esempio, la Toscana, affermando che il Decreto sicurezza sarebbe in conflitto con disposizioni di legge fiorentine.
Un sindaco può non applicare una legge perché ritiene che sia in conflitto con la Costituzione, con i trattati internazionali o con un’altra legge di rango superiore? – No, perché in caso di conflitto tra norme non spetta a lui stabilire quale norma debba prevalere, nemmeno se decide di applicare la norma di rango superiore. Finché la Corte costituzionale non stabilisce l’eventuale anticostituzionalità di una legge, qualunque cittadino deve applicarla e farla applicare, a maggior ragione se è un sindaco, in quanto funzionario dello Stato. Non è neppure possibile sapere in anticipo quali conseguenze avrebbe un’eventuale decisione costituzionale che desse indirettamente ragione a un sindaco che disapplica una norma: la validità ed efficacia ex nunc o ex tunc delle sentenze di anticostituzionalità dipendono da diversi fattori specifici.
«Disobbedienza civile» o disobbedienza e basta?
E’ giustificato parlare di «disobbedienza civile» da parte dei sindaci? – No ed è molto grave che si abusi di questo termine, svuotandolo del suo nobile significato. Disobbedienza civile vuol dire disobbedire a una legge ingiusta per suscitare pubblica riprovazione e indurne la modifica. Ciò vale particolarmente nei casi di leggi promulgate da dittature, regimi coloniali o Stati che ignorano i diritti fondamentali. In democrazia, invece, le leggi vengono promulgate da un Parlamento liberamente eletto e attraversano vari gradi di esame, oltre al voto in aula. Se si prestano comunque a critiche di legittimità, esistono organi deputati a riesaminarle. Se si accetta che ogni cittadino, anche se sindaco, possa decidere in modo autocefalo se una legge sia più o meno «giusta,» ogni categoria di soggetti che si ritenga danneggiata da una legge democraticamente votata dal Parlamento avrebbe titolo di ignorarla, delegittimando così la maggioranza e lo Stato stesso. Per questo motivo, tutti gli organi dello Stato sono tenuti a rispettare e far rispettare le leggi, senza eccezioni. Se non si sentono pronti a questa fedeltà, devono lasciare la loro funzione. Lo si era già detto per il caso di Riace, che presenta tratti comuni con la vicenda di questi giorni. Non dimentichiamo mai che le leggi, in uno Stato di diritto, sono promulgate con il consenso espresso dai cittadini attraverso i loro rappresentanti in Parlamento. Contestarle fuori dalle procedure previste significa delegittimare il principio stesso su cui si fonda lo Stato democratico.
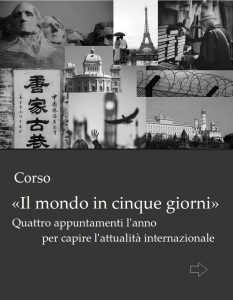
E’ adeguato paragonare i «sindaci ribelli» a Gandhi, a Rosa Parks e ad altri grandi figure che con la loro disobbedienza civile e non violenta cambiarono il mondo? – Non siamo ridicoli.
E’ giusto citare in questo caso che la Costituzione tutela «lo straniero al quale sia impedito nel suo Paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche» e affermare perciò che l’abolizione della protezione umanitaria sarebbe contraria a questo principio costituzionale (art. 10)? La protezione umanitaria, abolita con il Decreto sicurezza, veniva concessa dallo Stato italiano in via subordinata alla protezione internazionale (asilo politico): significa che veniva accordata quando il cittadino straniero non aveva i requisiti per ottenere l’asilo politico, ma non poteva nemmeno essere respinto nel suo Paese, oppure esistevano gravi motivi per i quali l’Italia, se lo avesse espulso, avrebbe violato obblighi internazionali o costituzionali. L’articolo 10 della Costituzione, appena citato, parla di «esercizio delle libertà democratiche [dello straniero] nel suo Paese:» si riferisce perciò ai casi di persone perseguitate per motivi politici, quelli previsti dal diritto d’asilo e codificati nella Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati. Se un cittadino straniero ha ricevuto protezione umanitaria, ciò significa che lo Stato italiano ha già accertato che non ha diritto all’asilo, perciò le sue libertà democratiche non sono minacciate nel suo Paese, anche se gli è stato permesso di restare in Italia per ragioni umanitarie, non politiche. Mi sembra dubbio, perciò, che si possa invocare questo articolo costituzionale, in questo caso.
Non abusiamo delle parole
E’ giusto dire che il Decreto sicurezza è razzista? – No e non bisogna dare alle parole delle interpretazioni analogiche fuori luogo, altrimenti non si capisce più nulla. Razzismo significa discriminazione in base all’appartenenza etnica, al colore della pelle o ad altri elementi naturali e culturali che vengono colti come cause di degradazione della persona umana. E’ un atteggiamento odioso e, purtroppo, ancora molto diffuso. Le leggi sugli stranieri, però, tra cui quelle che codificano il diritto d’asilo e la protezione umanitaria, non si fondano su un criterio etnico, ma sul criterio della nazionalità, cioè dell’appartenenza di un cittadino a uno Stato in quanto elemento di diritto pubblico positivo (che non è il contrario di «diritto negativo,» ma indica lo ius in civitate positum, cioè quella categoria di diritti scritti dall’Uomo, non presenti in natura). Lo Stato è un sistema che amministra un territorio e una popolazione: da ciò deriva necessariamente che vi sono cittadini nazionali, appartenenti allo Stato, e cittadini esteri, che non vi appartengono. In conseguenza, il cittadino nazionale ha uno status giuridico diverso dal cittadino straniero. Lo stesso articolo 10 della Costituzione italiana, che viene richiamato in modo poco adeguato in queste ore, come detto sopra, afferma che «la condizione giuridica dello straniero e regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.» Se lo Stato riserva ai cittadini nazionali un trattamento diverso da quello che riserva agli stranieri, non può essere accusato di razzismo: fa il suo dovere. Lo straniero, naturalmente, deve sempre essere trattato rispettando i diritti fondamentali della persona umana e i trattati internazionali, ma nessuno può avere un diritto naturale o costituzionalmente garantito di vivere o trattenersi sul territorio di uno Stato diverso da quello di cui è cittadino. Per inciso, va ricordato che la protezione umanitaria è un istituto specifico del diritto interno italiano, non corrisponde ad alcun trattato internazionale, come invece il diritto d’asilo politico. L’Italia può modificarlo come crede, pur nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, s’intende.
E’ giusto affermare che se i sindaci applicano il Decreto sicurezza senza contestarlo si comportano come i gerarchi nazisti, che applicarono le leggi razziali del Terzo Reich e gli ordini di Hitler senza opporvisi? – No e queste comparazioni vanno evitate, perché sono indice di scarsa preparazione e nessun rispetto per le tragedie del passato. Sul piano del diritto oggettivo, le leggi del Terzo Reich e dell’Italia fascista erano promulgate da Stati totalitari che non ammettevano opposizione legale ai loro provvedimenti: l’Italia oggi è uno Stato di diritto, nel quale chi desidera contestare una legge può farlo secondo regolari procedure costituzionali. I gerarchi che applicarono le leggi razziali, del resto, furono condannati per quei crimini, alla fine della guerra. Sul piano dei diritti soggettivi, poi, le leggi razziali colpivano in modo del tutto arbitrario specifiche categorie di cittadini in base alla loro appartenenza etnica o religiosa (in particolare gli ebrei, ma anche sinti, rom e altre etnie considerate inferiori); le leggi che determinano lo status degli stranieri, al contrario, come detto sopra, non sono leggi razziali o contrarie ai principi di umanità (nel senso giuridico di questo termine), sono strumenti necessari di amministrazione del territorio e attuazione della sovranità dello Stato.
Ma allora il Decreto sicurezza va bene così? – No. Il decreto, almeno per quanto riguarda lo specifico aspetto della protezione umanitaria, appare frutto di superficialità e intaccato da una notevole misura di cinismo. E’ più che giusto preoccuparsi di cosa accadrà a coloro ai quali era stata concessa la protezione umanitaria e ora non potranno più accedere ai servizi dello Stato. Ciò non solo per elementari preoccupazioni solidaristiche, ma anche per la sicurezza interna dello Stato stesso: questi cittadini stranieri, ora, entreranno di fatto in clandestinità, diventando un problema per se stessi e per la collettività.
E’ male che non si siano previste modalità per affrontare adeguatamente le conseguenze di queste decisioni. E’ necessario quanto mai riordinare la materia migratoria, in Italia, ma questa non sembra essere la strada più efficace.


F. Verti says:
Grazie. E’ sempre salutare leggere le sue parole anche quando, anzi soprattutto quando, parto da opinioni diverse. L’uso preciso delle parole è la base del dialogo e del confronto politico. Purtroppo il ministro degli interni italiano e molti altri politici indirizzano l’attenzione di noi cittadini verso altri lidi, con il risultato di fomentare ideologie non così lontane dai periodi bui e stimolare contro risposte che alzano il clima di intolleranza. Riguardo al dissenso dei sindaci, vorrei aggiungere che su certi temi che provocano le nostre coscienze, non è lecito appellarsi ad una legge, ma è lecito aggrapparsi ai principi che ispirano quella legge. Per cui ricorrere legalmente può essere sbagliato, soprattutto da chi esercita un ruolo istituzionale, ma esprimere il proprio dissenso, finanche dimettendosi, può essere utile a creare un dibattito politico che porti a migliorare la legge stessa. Come esempio cito l’obiezione di coscienza al servizio militare. I primi obiettori andavano in carcere perché non era prevista dal nostro ordinamento giuridico, né tanto meno esisteva la possibilità di svolgere un servizio civile sostitutivo. Il “sacrificio” di quei primi obiettori e il sostegno culturale e politico che ne è seguito, ha permesso un cambiamento della legge.
Luca Lovisolo says:
Grazie per il Suo commento. Non ho scritto, infatti, che la disobbedienza civile è considerabile solo, ma «particolarmente nei casi di leggi promulgate da dittature […]». Anche in una società governata democraticamente si può giungere alla necessità di disobbedienza civile: si tratta però di casi più che eccezionali, ad esempio dove mancano possibilità legali di opposizione. Non è il caso del Decreto sicurezza, tanto che diverse Regioni, nel frattempo, hanno annunciato ricorso presso la Corte costituzionale, cioè rispettando le procedure legittime. Il problema che sottolineo è l’abuso e lo svuotamento del principio di disobbedienza civile, per voler applicarlo ovunque. Da una parte, indebolisce il senso di questa azione, che nella Storia ha nobili precedenti; dall’altro, richiamare la disobbedienza civile per giustificare casi in cui si tratta di disobbedienza e basta, o peggio di propaganda, finisce con l’indebolire i fondamenti su cui si basa lo Stato di diritto, fondato sul rispetto della legge voluta dalla maggioranza. Qui, per giunta, la disobbedienza sarebbe attuata da funzionari dello Stato, che apre tutt’altro scenario di problemi. Cordiali saluti. LL
Flavia says:
Analisi molto chiara ed equilibrata, come sempre.
Luca Lovisolo says:
Grazie. LL